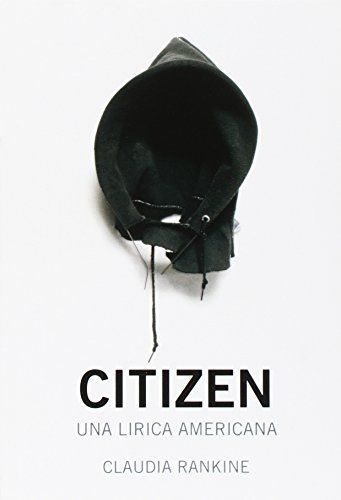giovedì 30 settembre 2021
mercoledì 29 settembre 2021
Linda Evangelista e quell'intervento di chirurgia che l'ha sfigurata: "Sono diventata una reclusa"
 |
| Linda Evangelista |
Linda Evangelista e quell'intervento di chirurgia che l'ha sfigurata: "Sono diventata una reclusa"
Dopo cinque anni di silenzio la top model ha svelato il motivo per cui è improvvisamente sparita dal radar.
DI EMANUELA GRIGLIÉ
24/09/2021
"Sfigurata" per colpa di un trattamento estetico. Ha deciso di non nascondersi più, anzi di raccontarlo perché, dopo anni nell’ombra, voleva che tutti sapessero e voleva liberarsi dalla vergogna. Lei è Linda Evangelista, anzi Linda perché - con Naomi, Kate e Claudia e le altre - fa parte di quella squadra di top model diventate mitologiche negli anni Ottanta e Novanta. Famosissima per i suoi occhi dal colore indefinibile, oggi Linda, che ha 56 anni, afferma di essere "deformata in modo permanente" dopo che un intervento di chirurgia estetica (non chirurgica) apparentemente di routine è andato storto. Lo ha raccontato in un post su Instagram.
"Ai miei follower che si sono chiesti perché non ho più lavorato mentre le carriere delle mie colleghe continuavano a fiorire, ecco: il motivo è che sono stata brutalmente sfigurata da una procedura che ha fatto l’opposto di ciò che aveva promesso e mi ha lasciato per sempre deformata anche dopo due dolorosi e inutili interventi correttivi". La ex modella ha spiegato di essersi sottoposta a una procedura nota come CoolSculpting, ovvero il "congelamento" del grasso del corpo, una procedura simile al body conturing, che provoca una riduzione non invasiva del tessuto adiposo attraversi il raffreddamento cutaneo localizzato. Ma che nel suo caso ha scatenato un raro effetto collaterale che ha provocato una metamorfosi radicale del suo aspetto al punto da renderla irriconoscibile.
"Ho sviluppato una iperplasia adiposa", aggiunge Evangelista, "che non solo ha messo in crisi le mie fonti di sussistenza, mi ha provocato anche una profonda depressione e un enorme disprezzo del mio aspetto. In questo processo mi sono chiusa in me stessa. Sono diventata una reclusa".
Linda ha detto di non aver detto niente per cinque anni, e ora la sua rivelazione ha scatenato una corsa alla solidarietà nel mondo della moda e non solo. "Sei e sempre sarai una supermodella", ha scritto lo stilista di Moschino, Jeremy Scott. "Ti amo, cara Linda", dice Marc Jacobs. Mentre Naomi Campbell ha "applaudito al coraggio e alla forza" dell’amica. "Ti applaudo per il tuo coraggio e la tua forza nel condividere la tua esperienza e non esserne più tenuta in ostaggio. Non riesco a immaginare il dolore che hai attraversato mentalmente negli ultimi cinque anni”. Linda Evangelista ha annunciato una causa legale contro i responsabili del trattamento estetico finito male, "per liberarmi della mia vergogna".
Canadese, figlia di immigrati italiani originari della provincia di Frosinone, ricordiamo che Evangelista era stata al centro di uno scandalo nel 2011 quando aveva rivelato che il padre di suo figlio - di cui non aveva mai detto il nome - era l'imprenditore francese François-Henri Pinault. Anche in quel caso seguì un processo finito poi con un accordo sul mantenimento del bambino nato nel 2006.
lunedì 27 settembre 2021
Dalla camera di Testaccio, all’attico condiviso con Alberto Moravia, i luoghi preferiti di Elsa Morante

Dalla camera di Testaccio, all’attico condiviso con Alberto Moravia, i luoghi preferiti di Elsa Morante
Ciascuna delle opere della scrittrice potrebbe essere ricondotta alle stanze dentro cui prese forma.
DI ALESSIA VITALE 03/05/2021
sabato 25 settembre 2021
Il nuovo libro di Claudia Rankine è un inventario del presente in cui la poesia incontra la realtà

Il nuovo libro di Claudia Rankine è un inventario del presente in cui la poesia incontra la realtà
Dall'autrice di Citizen, un nuovo imperdibile volume.
11/08/2021
“Sull’autobus due donne discutono se Rudy Giuliani dovesse inginocchiarsi di fronte alla regina d’Inghilterra quando è stato nominato cavaliere,” racconta la voce di Non lasciarmi sola, il nuovo libro della poetessa statunitense Claudia Rankine. Sean Connery e Mick Jagger lo avevano fatto. Alla fermata giusta, scesa dall’autobus, ripensa all’attacco del World Trade Center. Il paragrafo successivo è occupato da una citazione del poeta Wallace Stevens che parla di immaginazione e nobiltà.
I libri di poesia si leggono raramente e ancora più raramente capita di consigliarli agli altri: questo genere letterario sembra destinato a una forma di inattualità che lo rende un improbabile oggetto di promozione editoriale. Per qualche ragione, si fa fatica a definire una raccolta di poesia ‘nuova’ o ‘appena uscita’, perché rimanda a un’idea di consumabilità, di tempestività, di adesione al momento presente che sembra sminuire o addirittura insultare il lavoro poetico; ogni libro di poesia pare dover essere futuro o antico. Eppure Non lasciarmi sola. Una lirica americana., il libro di Rankine edito da 66thand2nd con traduzione di Isabella Ferretti, è capace di raccontare il presente meglio di tanta della narrativa che della contemporaneità ricalca solo l’immaginario spicciolo - i lavori mal pagati, le relazioni traballanti, il futuro che diventa sempre ipotetico. Più che raccontare il mondo forse bisognerebbe dire che lo rappresenta nelle sue strutture essenziali, ne restituisce nel modo in cui lo comprendiamo e lo esperiamo.
Non lasciarmi sola precede cronologicamente il già pubblicato Citizen, un libro che più di altri è stato capace di raccontare l’esperienza dei neri americani, di cambiare i termini della discussione sulla razza. Se sulla copertina di Citizen campeggiava un cappuccio nero - un'immagine che evoca insieme il KKK, i prigionieri di Abu Ghraib, ma soprattutto l'omicidio del diciassettenne Trayvon Martin per mano del vigile George Zimmerman, che lo aveva considerato “sospetto” e “pericoloso” proprio perché indossava una felpa - su quella di Non lasciarmi sopra c’è un televisore con lo schermo sintonizzato sul rumore bianco.
“Di notte guardo la televisione perché mi aiuta a prendere sonno, oppure la guardo perché non riesco a dormire,” si legge in uno dei paragrafi che compongono il libro e quella televisione sintonizzata sul canale zero sembra rappresentare contemporaneamente la disconnessione dal mondo, il desiderio di oblio e l’irricevibilità delle notizie. Pubblicato per la prima volta nel 2004, a poca distanza dall’attacco alle Torri Gemelle, Non lasciarmi sola è una riflessione sulla morte, gli psicofarmaci, la malattia e la solitudine - sull’umanità come corpo e la parola come strumento di incontro possibile con l’altro (alla fine, accanto all’immagine di un cartellone che recita QUI, scrive “Paul Celan ha detto che la poesia non è diversa da una stretta di mano. Io non vedo alcune differenza di principio tra una poesia e una stretta di mano - così Rosemary Waldrop ha tradotto dal tedesco”).
La stessa televisione punteggia tutto il testo, questo lungo poema per frammenti, interrotto da spazi bianchi, ritagli di giornali, elenchi di compagnie farmaceutiche, fotografie di uomini e donne uccisi: Non lasciarmi sola è una specie di inventario del presente fatto di oggetti incongrui e corredato da un lungo apparato di note che riconsegna ognuna delle citazioni al contesto originario. È insieme una lista di scomparse e un tentativo di dire queste cose, perché sono esistite.
Ricordo che una volta in un incontro Ilide Carmignani aveva ipotizzato che la crescente popolarità della poesia avesse a che fare con Instagram: il fatto che i testi fossero brevi faceva sì che entrassero perfettamente nel quadratino della app; la poesia era, insomma, più fotografabile di altre forme. Leggendo Non lasciarmi sola mi viene il dubbio che la ragione sia un’altra, cioè che la poesia (questa poesia, per lo meno) sia la forma migliore di rappresentazione della realtà per come la viviamo. Le immagini giustapposte, la possibilità di raccontare senza archi narrativi ed evoluzioni, l’assenza di riempitivi, le voci altrui che si sovrappongono alla nostra. Come nel brano citato in apertura, la vita è la collezione delle apparizioni e delle sparizioni, delle cose che ci attraversano per un secondo o che ricordiamo - la letteratura, la morte di tremila persone in mondovisione, due donne sull’autobus, un politico.
Se la televisione che evoca Rankine ci permetteva, cambiando da un canale all’altro, di passare da uno spot di macchine a immagini di guerra a commedie romantiche nello spazio di un attimo, a distanza di più di quindici anni questo montaggio incomprensibile non ha fatto che intensificarsi - non solo le notizie che ci raggiungono ovunque, cambiandoci la vita in mezzo a spazi indifferenti, ma qualsiasi timeline affianca le foto di vacanze a disastri climatici, annunci di morte, aneddoti divertenti, polemiche e ricordi, canzoni.
Se prima quel montaggio metteva in forma visiva la contemporaneità di eventi incongrui tra loro, creando relazioni dove prima non c’erano, adesso questo montaggio include anche la nostra vita, i nostri post annegati tra un mondo e l’altro, le stories su Instagram che tengono insieme tutto, noi, gli altri, il personale, il tempo là fuori, in una specie di haiku perenne, senza risoluzione.
Scrivevo prima che tanti romanzi contemporanei sembrano solo mimare la realtà: ogni tanto uno dei personaggi apre un computer, manda una mail, riceve un messaggio, qualcuno si ossessiona con una persona conosciuta su Instagram o inventa una personalità fittizia da usare online. In molti casi si tratta di effetti di realtà, segnali per indicare il momento in cui il libro è stato ambientato, ma poi questi libri preferiscono la consequenzialità alla compresenza agerarchica di eventi; del resto sono romanzi, tentativi di dare ordine al mondo, sistemi di realismo. Forse è alla poesia che possiamo guardare quando il realismo non sembra più efficace per spiegare il rumore bianco dentro cui viviamo, l’inconciliabilità del corpo con il mondo.
Rankine, con la sua poesia che usa le immagini, le citazioni, che è in bilico tra la lirica e il saggio, prova a farlo, a dare quella stretta di mano di cui parlava Celan (“la stretta di mano è il nostro rituale convenzionale per affermare (Io sono qui) e consegnare il proprio io a un’altra persona”). Non è la sola - nell’introduzione a Nuova Poesia Americana, la collana antologica di poesia curata da John Freeman e Damiano Abeni per Black Coffee, lo stesso Freeman scriveva “ciò che abbiamo davanti agli occhi oggi non è una generazione di poeti, bensì un nuovo modello di poesia americana che ci restituisce sotto forma di personalità poetiche tutta l’intensità delle pressioni cui è sottoposto” e il successo di autori come Kae Tempest, Ben Lerner, Ocean Vuong sembra confermarlo.
“Come posso dirle, Comprendi senza sforzo che l’uomo rimane, a volte, pensieroso, quasi volesse piangere. Cito, riformulandoli un po’, i versi del poeta César Vallejo perché Vallejo è quello che più si avvicina a spiegare che qualunque forma di conoscenza può essere una ricetta contro la disperazione, ma questa risposta non la accetterebbe, non potrebbe mai usarla come blurb per il libro”.
BAZAARvenerdì 24 settembre 2021
giovedì 23 settembre 2021
Alberto Moravia / Vita, opere e curiosità sullo scrittore
 |
| Alberto Moravia |
Alberto Moravia: vita, opere e curiosità sullo scrittore
Scopriamo insieme la vita, le opere e alcune curiosità da non perdere di uno dei più importanti romanzieri del XX secolo: Alberto Moravia.
Pubblicato il 26-09-2020
Alberto Moravia (1907-1990) è stato uno dei più importanti romanzieri del XX secolo. Non fu solo scrittore: collaborò alle principali testate del suo tempo, a lungo impegnato come reporter di viaggio e critico cinematografico.
Nel corso della sua carriera ha consegnato ai lettori oltre 30 opere, di cui alcune possono vantare anche celebri trasposizioni cinematografiche. I temi centrali affrontati dai suoi racconti e dai suoi romanzi sono l’aridità morale, l’ipocrisia, l’alienazione, la sessualità, l’incapacità di raggiungere la felicità.
Scopriamo insieme qualche curiosità su Alberto Moravia, prima di dedicarci alla sua vita e alle sue opere.
Le 5 curiosità che forse non sai su Alberto Moravia
- In realtà si chiamava Alberto Pincherle
Ebbene sì, Alberto Moravia è uno pseudonimo: il suo nome reale era Alberto Pincherle. Moravia è il secondo cognome della famiglia paterna. - I suoi intrecci familiari sono piuttosto interessanti
La famiglia Pincherle-De Marsanich vanta intrecci piuttosto curiosi. Alberto Moravia era il cugino della poetessa Amelia Rosselli e di Carlo e Nello Rosselli; parente acquisito del sindaco di Roma Ernesto Nathan; suo zio era il noto giurista e senatore Giuseppe Zanardelli; era imparentato con Enrico Fermi e con Augusto De Masanich, sottosegretario di Stato durante il Fascismo. - Raggiunse a stento la licenza ginnasiale
Moravia era un grande lettore: fin da ragazzo conosceva i grandi classici della letteratura europea, parlava francese e tedesco. A causa di una tubercolosi ossea, però, fu costretto a dedicarsi agli studi in autonomia: frequentò il liceo solo un anno, quanto bastava per ottenere una risicata licenza ginnasiale. - La sua vita sentimentale destò un certo scalpore
Alberto Moravia fu marito di Elsa Morante dal 1941 al 1962. Successivamente, convisse con Dacia Maraini, di circa trent’anni più giovane, e nel 1986 sposò Carmen Llera, di ben 45 anni più giovane. - Ricevette 15 candidature al Nobel, senza mai vincerlo
Dal 1949 al 1966 Moravia ricevette 15 candidature al Nobel per la letteratura, senza mai riuscire a vincere l’ambito premio. A proporre il suo nome, tra gli altri, anche Eyvind Johnson (Nobel 1974) e Maria Bellonci.
Alberto Moravia: vita e opere
Alberto Moravia (Pincherle) nasce a Roma il 28 novembre 1907 in un’abbiente famiglia borghese. Nel 1916, a soli nove anni, è colpito da una forma di tubercolosi ossea che lo costringe a letto per cinque anni (due dei quali trascorsi in un sanatorio a Cortina d’Ampezzo). Riesce a frequentare il liceo solo per un anno, conseguendo la licenza ginnasiale, suo unico titolo di studio.
Impossibilitato a condurre una vita attiva come gli altri ragazzi della sua età, Moravia si concentra sulla lettura, impara il francese il tedesco e inizia a scrivere. I suoi primi racconti appaiono sulla rivista “Novecento”, con cui inizia a collaborare nel 1927.
Nel 1929 pubblica a sue spese il suo primo romanzo, Gli indifferenti, che fin da subito riscuote successo di critica. Si tratta del primo romanzo esistenzialista italiano, che narra la storia di una famiglia i cui componenti resteranno vinti dalla loro apatia.
Proseguono le sue collaborazioni con quotidiani e riviste ("La Stampa", “Oggi”, “Gazzetta del Popolo”) e nel 1935 si reca negli USA per tenere alcune lezioni sul romanzo italiano. In seguito, parte per la Cina come reporter per la “Gazzetta del Popolo”.
Per evitare la censura, durante gli anni del Regime è costretto a scrivere racconti allegorici e surreali, distaccati dalla realtà, e a pubblicare i suoi articoli sotto pseudonimo. Il suo romanzo La mascherata, una violenta satira indiretta nei confronti del regime, viene sequestrato.
Nel 1941 sposa Elsa Morante, conosciuta quattro anni prima. Con lei, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, si rifugia in Ciocaria, dove trae ispirazione per il romanzo La ciociara, che, scritto in due riprese, descrive la disperata realtà italiana durante gli ultimi anni di guerra.
Con la Liberazione, Moravia torna a Roma e riprende la propria attività giornalistica collaborando con altre testate, tra cui “Il Popolo di Roma”, “Il Mondo”, “L’Europeo” e il “Corriere della Sera”.
Anche la sua produzione narrativa prosegue e la sua fortuna letteraria aumenta, con la pubblicazione de La romana (1947), La disubbidienza (1948) e Il conformista (1951). I suoi Racconti vincono nel 1952 il premio Strega e negli stessi anni iniziano le traduzioni delle sue opere all’estero e le trasposizioni cinematografiche tratte da suoi racconti e romanzi (tra le più celebri, ricordiamo La romana di Luigi Zampa, La ciociara di Vittorio De Sica con Anna Magnani, Il disprezzo di Jean-Luc Godard, La noia di Damiano Damiani e Gli indifferenti di Francesco Maselli).
Nel 1953 fonda con Alberto Carocci la rivista "Nuovi Argomenti", poi sede del celebre saggio L’uomo come fine. Inizia a collaborare con “L’espresso”, per cui tiene una rubrica di critica cinematografica, e scrive Il disprezzo.
Nel 1960 pubblica La noia e nel 1962, separatosi da Elsa Morante, inizia a convivere con Dacia Maraini, conosciuta a fine anni Cinquanta. Con Maraini si reca negli anni successivi in Cina, Giappone e Corea come corrispondente del “Corriere” e, per diciotto anni consecutivi, insieme alla compagna e ad altri amici (tra cui Pier Paolo Pasolini e Maria Callas) visita numerosi paesi africani. I resoconti di questi viaggi sono poi stati pubblicati nei due volumi La rivoluzione culturale in Cina e A quale tribù appartieni?. Dall’esperienza in Giappone nel 1982 scriverà il saggio L’inverno nucleare.
Nel 1986 sposa Carmen Llera, sua nuova compagna, di 45 anni più giovane. Quattro anni dopo, il 26 settembre 1990, viene trovato morto nel bagno del suo appartamento.
SOLO LIBRIlunedì 20 settembre 2021
Afarin Sajedi / Donne
sabato 18 settembre 2021
Lucio Mastronardi / Calzolaio e Maestro di Vigevano
 |
| Lucio Mastronardi |
Lucio Mastronardi: Calzolaio e Maestro di Vigevano
Gabriele Sabatini
12 Marzo 2018
«Fare soldi, per fare soldi, per fare soldi: se esistono altre prospettive, chiedo scusa, non le ho viste. Di abitanti, cinquantasettemila, di operai venticinquemila, di milionari a battaglioni affiancati, di librerie neanche una. Non volevo crederci. Poi mi hanno spiegato che ce n’era una in via del Popolo [...]. Chiusa per fallimento, da più di un anno. Diciamo che il leggere non si concilia con il correre e qui, sotto la nebbia che esala dal Ticino, è un correre continuo e affannoso».
 |
| Lucio Mastronardi |
Mastronardi, ancora venticinquenne, gli si presentò nel gennaio del 1956 inviando alcuni racconti: fra i due si strinse un rapporto che diede come primo esito, appunto, la pubblicazione del Calzolaio, storia di ascesa e caduta di Mario Sala e di sua moglie Luisa, artigiani della scarpa che, per dirla con Eugenio Montale, non sono «singole figure a pieno rilievo, perché i due presunti protagonisti sono presto assorbiti da una folla; non azioni che si svolgano secondo un disegno, ma il quotidiano brulicante trescone di branchi di castori umani che lottano per elevarsi dall’ago (dal trapano) al milione, e che poi ricadono nella condizione servile dalla quale sono partiti».
Come spesso accade con Vittorini, non si possono omettere cenni ai suoi decisi interventi nel testo, e infatti, molte modifiche al dattiloscritto vengono richieste dallo scrittore siciliano. È un editing che il deus ex machina, Italo Calvino, approva quando giudica il dattiloscritto «sempre di più sorprendente e unico come rappresentazione di un mondo nella sua perfetta rozzezza».
Meno soddisfatto, forse, l’autore. Non già per i troppi interventi, ma per i troppo pochi, e prima che il testo venisse ristampato come romanzo autonomo nel 1962, Mastronardi corregge ancora poiché ci trova «troppe parti sforzate e troppa sociologia. Ogni volta che mi leggo su “Il Menabò” provo crisi di angoscia».
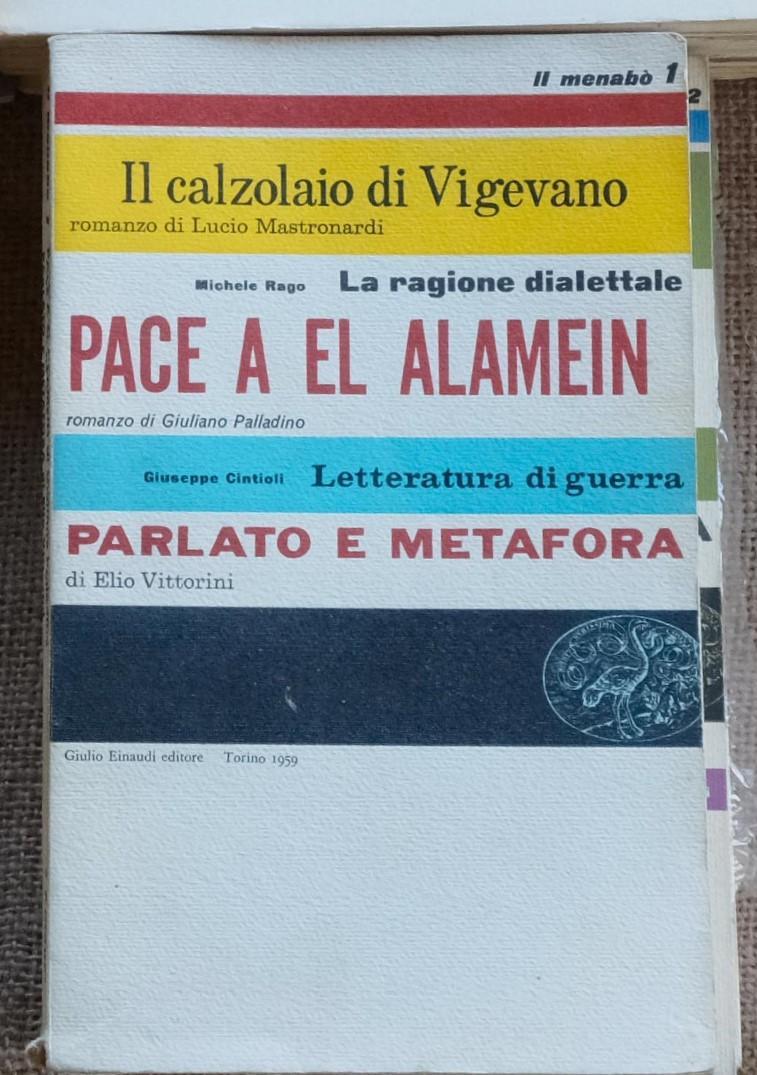
Menabò n.1.
Sulla scorta di questa prima, riuscita prova, lo scrittore comincia a lavorare al suo romanzo più famoso, facendo muovere il protagonista, Antonio Mombelli, nel contesto lavorativo proprio di scrittore e personaggio: la scuola. Scrive a Calvino offrendogli il dattiloscritto: «E poi i maestri, non so se sia l’ambiente o il lavoro, ma hanno tutti qualche mania, qualche pallino! È un mondo insomma interessante, e triste. Interessante per chi è fuori dalle mura, triste per chi è dentro».
Di Mastronardi, la famiglia di origine tutta era legata a quel mondo: la madre era maestra elementare; il padre, ispettore scolastico. Lucio Mastronardi insegna dapprima nella casa circondariale del capoluogo lomellino, poi, dal 1955, alla scuola elementare.
Il nuovo romanzo parla del maestro Mombelli e di una moglie spesso pronta a umiliarlo, offenderlo, una donna che brama l’ascesa sociale, tanto da diventare imprenditrice sfruttando la liquidazione del marito, dimessosi per seguire la chimera imprenditoriale. Stavolta non c’è spazio per l’ascesa, ma solo per la caduta.
L’afflato del giudizio calviniano ne determina la pubblicazione nella collana “I coralli” nel 1962: «Altra lettura eccezionale – scrive a Vittorini – un lungo nuovo romanzo di Mastronardi: Il maestro di Vigevano, che non so se e come pubblicare, perché è di un’oscenità, uno schifo dell’umanità che fanno restare senza fiato, ed è pieno di motivi assolutamente paranoici, ma tutto insieme è una cupa opera di poesia in cui non ci sarebbe da toccare una virgola».
Sono entrambi i romanzi della meschinità, della miseria umana: Mastronardi descrive i primi anni del boom economico ponendo tutti davanti a uno specchio che riflette l’immagine sinistra dell’affermazione economica come unico interesse; la bassezza di parvenu della borghesia in grado di accumulare rapidamente e rapacemente fortune ingenti, invidiati da chi ha provato la stessa strada con minor successo: «Vigevano è per me il mondo in piccolo – dichiarava l’autore – una realtà fatta di grettezza. Di avarizia, di sporcizia, ma anche una realtà sensibile a ogni mutamento politico e sociale. Un microcosmo, insomma». Che forse incarna sì anche l’attivismo di quei primi anni Sessanta, ma se ne fa sommergere.
L’iter di stampa del Maestro non è dei più rapidi: il dattiloscritto viene smarrito e i lavori si bloccano. Già tempo prima Mastronardi fremeva, e chiedeva notizie che non arrivavano. Attesa, ritardi che si innestano in un carattere delicato, tendente alla depressione come quello del vigevanese («Una sensibilità di scorticato vivo», ricorderà Calvino dopo il suicidio dello scrittore).
Mastronardi il 1° ottobre di quello stesso anno dà in escandescenza contro un ferroviere. Fermato dalla polizia, viene obbligato al ricovero. Per questo fatto, la madre dello scrittore, Maria, invia una lettera a Calvino. Di nuovo, si chiedono notizie del romanzo; ella conosce lo stato d’animo del figlio: «Sì, le preoccupazioni letterarie hanno avuto parte fondamentale nella depressione di Lucio. Quel povero ragazzo, che trascina da dieci anni l’ingrato lavoro nella scuola, […] vede, o s’illude di vedere in ogni sua manifestazione extra, un miraggio di liberazione. […] La sua suscettibilità ferita, la sua disperata speranza fu rivolta al suo libro: fu dolorosamente sorpreso quando lo seppe smarrito, si rinfrancò quando lo seppe ritrovato, si persuase che così com’era non era possibile di pubblicazione e intanto attendeva con orgasmo, guardando la scuola che si riapriva a giorni e fatalmente sembrava inghiottire tutti i suoi sogni».
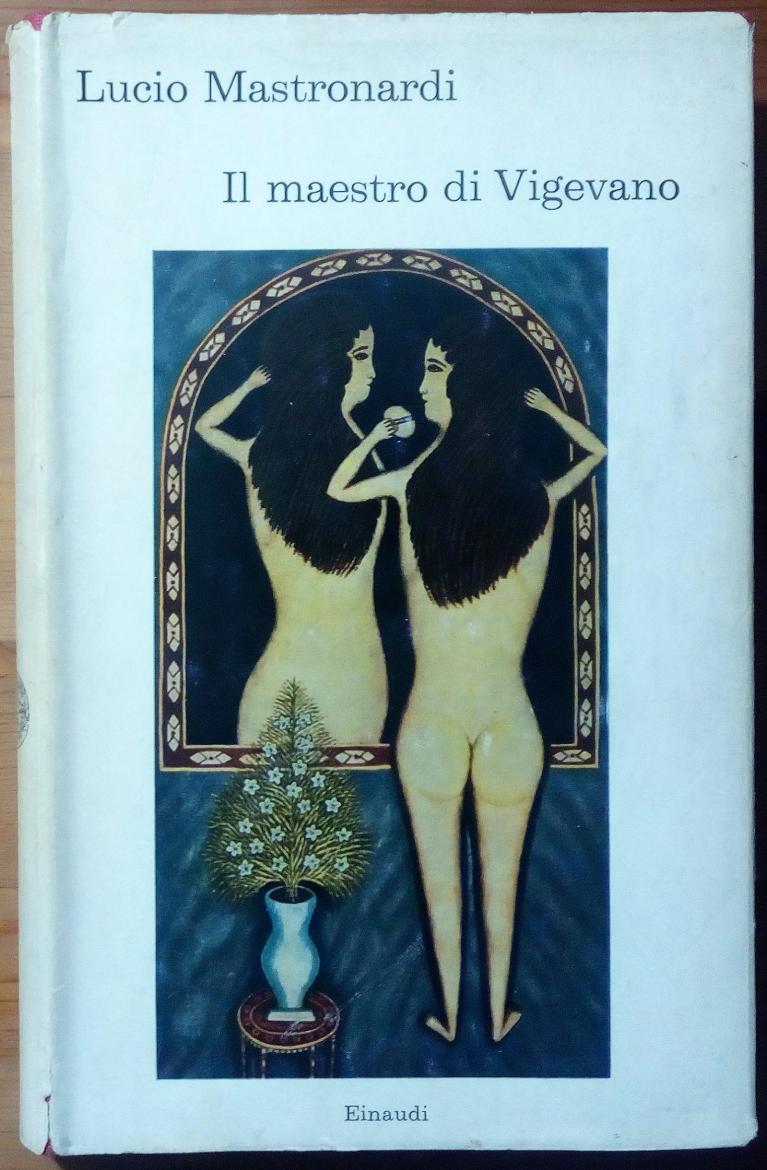
Maestro di Vigevano.
Ma non c’è solo la copia smarrita e ritrovata: la casa editrice opera una attenta revisione soprattutto perché, oltre a pagine piene di talento e humor, Calvino ne ravvisava altre non accettabili. E che davvero vi fossero delle parti non idonee per la Einaudi emerge anche dal risvolto di copertina: «Abbiamo rispettato il testo di Mastronardi nella sua integrità (solo smussando qualche punta) coi suoi motivi ossessivi e visionari e crudeli, anche là dove sentivamo che offendeva il nostro gusto, [...] perché siamo sicuri che nell’insieme tutto si tiene, che il libro sotto le sue rozze spoglie ha una coerenza di struttura molto solida».
Non certo la più amichevole delle presentazioni, ma di sicuro una strada per incuriosire i lettori, che non mancano: 80.000 le copie vendute dopo l’uscita (ma solo 500 fra i quasi 60.000 abitanti di Vigevano). È dunque fredda l’accoglienza entro le mura cittadine, ma calde sono le reazioni: una mattina Mastronardi non si reca a scuola e si fa sostituire: «È stata una fortuna. Una maestra ha ravvisato nell’ispettore Pereghi suo marito. È scesa nella mia aula con un randello, ha trovato il supplente. Il giorno dopo, mi sono barricato nell’aula. Per fortuna che la maestra ha chiesto dieci giorni di vacanza».
Inaspettatamente, per i fatti dell’anno precedente, quando l’acceso alterco con il controllore ferroviario lo portò al ricovero, il 14 ottobre 1962 Mastronardi – che non sapeva di essere stato processato per direttissima e condannato – viene tratto in arresto. Lo rilasciano due giorni dopo per un vizio di forma, ma è la nube che prelude alla tempesta. Viene allontanato dalla scuola e dall’autunno del 1963 trasferito come bibliotecario ad Abbiategrasso. Luciano Bianciardi, altro autore che guardava attentamente alle conseguenze del boom economico e che sempre nel 1962 pubblicava La vita agra, commenta il fatto: «Le autorità scolastiche scacciano da Vigevano Lucio Mastronardi, e gli levano la nuova classe dopo un’ora di insegnamento, e lo confinano in segreteria. Hanno paura che contamini le anime dei fantolini. E pensare che fra cento anni intitoleranno una scuola al suo nome, versando, daccapo, la lacrimuccia sull’incomprensione dei suoi contemporanei».
Dopo questo romanzo, lo scrittore sembra smarrire la sua vena; Il meridionale di Vigevano (1964) chiude la trilogia e, pur rappresentando un altro tema centrale degli anni Sessanta, quello della migrazione interna da Sud a Nord, nel suo essere un romanzo di denuncia sociale non restituisce quell’amalgama di malignità, disperazione e sberleffo del mondo borghese tipico delle prime due opere. In fase preparatoria, Calvino approva molti brani, ma ne boccia altrettanti, soprattutto il finale: «Forse c’è dentro un’idea bellissima, ma ci capisco poco, materialmente, quello che succede. Cos’è questo posto dove bevono delle vecchie su dei paglioni? Non capisco niente».
L’autore stesso comprende che il filone vigevanese si è ormai esaurito, e presto si interromperà anche il rapporto con la Einaudi, con cui non pubblicherà i lavori successivi, passando a Rizzoli. Ha infatti sapore di commiato una lettera indirizzata a Calvino nel novembre del 1963, lettera che segnala anche l’opinione, evidentemente difforme da quello della casa torinese, sui suoi tre libri: «Con l’ultimo romanzetto, io ho chiuso una stagione della mia vita. […] Ho fatto tre libretti. Il calzolaio mi sembra quasi riuscito come racconto, e fallito come romanzo, […] Il maestro mi sembra mondano, anche se sincero. L’ultimo è quello che mi va di più. Se non altro è pacato. Adesso voglio ricominciare da capo».
venerdì 17 settembre 2021
Marco Belpolite / Smoke
 |
| Illustration by Marie Real |
Marco Belpolite
Smoke
Da ragazzo ho fumato. Sigarette offerte dagli amici. Poi ho cominciato a comprare i pacchetti. Erano le MS, una specie di Marlboro, solo più economiche. Poi di colpo, anni dopo, ho smesso. Non so perché, ma non mi piaceva più. Forse ero diventato grande e non ne avevo più bisogno. Le sigarette mi erano servite a fare società, a entrare nel gruppo, in una compagnia, a far parte di una setta. Non solo maschile, perché alla mia epoca anche le donne fumavano. Insieme ai maschi. Si fumava e si scambiavano parole. Si amoreggiava tra un tiro e l’altro. Avete presente la bellissima fotografia di Mario Dondero, quella dei ragazzi irlandesi che stanno fumando appoggiati a un muretto? Ragazzini. Fumare faceva diventare grandi. Poi di colpo, è arrivato il proibizionismo. Fumare faceva male, malissimo. È accaduto negli anni Novanta. Niente più fumo da nessuna parte. Tutto questo mi viene in mente leggendo e guardando il bellissimo libro di John Berger e Selçuk Demirel, Smoke (tr. it. di Maria Nadotti, € 9). Sono poche frasi che accompagnano le tavole del disegnatore turco, collaboratore di quotidiani, illustratore. O piuttosto il contrario: sono le frasi di Berger ad accompagnare i disegni, perché questi formano un racconto parallelo e convergente con quello dello scrittore inglese. Cosa dice Berger?
Due pagine di disegni stupendi con omini stilizzati. Da contemplare per capire cosa è la fantasia quando si trasforma in segno: rasentano l’onirico. La perversione ha che fare con il sogno? O con l’incubo? Fatto sta che da rito collettivo, dopo la crociata salutista, il fumo si è trasformato in un vizio privato, una perversione appunto. Tutto ora è così. Azzardo: persino il sesso. Ma questo non lo possono ancora proibire, se no ci estinguiamo. Prima o poi ci arriveremo: fa male! Ci sarà allora una macchina per inseminare, un sistema per farlo senza il sesso, trasformato in una perversione individuale (ma è solo un’immaginazione, forse un incubo, non so, forse esagero,però…). Fatto sta mentre vengono perseguiti a termini di legge i fumatori, il pianeta è invaso dai fumi dei gas industriali. Si riscalda sempre più. A Pechino non respirano più. Sono sicuro che il neopresidente americano, Donald Trump, che non farà nulla contro i gas di scarico di automobili, anzi li moltiplicherà, non fuma. Lui deve essere un salutista, uno di quei tipi che per campare a lungo hanno messo al bando il fumo. L’aspetto di vizioso, per via dei capelli tinti, e non solo, ce l’ha, ma credo proprio che non fumi. Gli interessa più il sesso, e almeno per questo siamo sicuri che non lo proibirà (o forse no, come i dittatori proibirà in pubblico quello che coltiva in privato). Berger ha una parola anche per la Volkswagen: “mentiva sui gas di scarico delle sue automobili”. Finale: i fumatori ostinati, banditi dai luoghi pubblici, sia all’aperto che al chiuso, vagavano verso gli stessi nascondigli, ed erano felici di incontrarsi come fuorilegge. Giusto il tempo per una sigaretta e una storia…”.
Hanno sempre fumato operai e intellettuali, uomini semplici e geni. Ricordate Hannah Arendt con la sigaretta eternamente in bocca? E Jean Paul Sartre? Se fumavano loro, perché non possiamo farlo noi? No! Non si fa. Fa male. Vero, ma perché siamo entrati in questa spirale persecutoria, perché ci colpevolizziamo a vicenda, perché il Potere persegue i fumatori? Ci vogliamo conservare per vivere più a lungo. Poco olio, molta insalatina. Niente carne, niente salumi. E tutto il resto, fumo compreso. Berger lo dice in modo chiaro ed efficace. Siamo sempre più longevi, ma anche sempre più soli. Quasi quasi torno a fumare, se serve per stare insieme, per scambiarci pareri, racconti di viaggi reali e immaginari, se serve per pensare alla lotta di classe che hanno abolito da mo’ e nessuno sa più cosa sia. Vedi Trump, e poi muori.