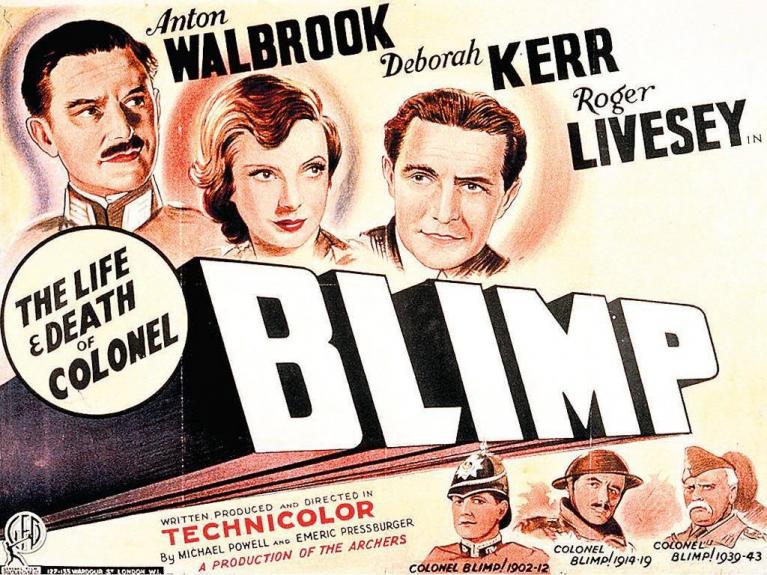Bizzarro il destino.
Per ragioni di semplice ordine alfabetico, sugli scaffali delle librerie i loro nomi saranno per sempre vicini. Morante-Moravia. Un amore sfortunato e a tratti violento quello che unì due dei più grandi letterati del secolo scorso. Fughe e ritorni, distacchi e riavvicinamenti, scenate e dispetti. Furibondi litigi in pubblico e "disperata dedizione", come lo scrittore romano ebbe a definire il sentimento che Elsa Morante provava per lui.
La loro storia comincia nel 1936 quando Alberto Moravia, di solida famiglia borghese e già reduce dal successo de Gli Indifferenti, il suo romanzo d’esordio, conosce Elsa, nata come lui a Roma nel 1912.
«Quando l'ho conosciuta - dirà nel 1971 allo scrittore e amico Enzo Siciliano - Elsa abitava in un piccolo appartamento molto carino a corso Umberto. Non aveva letteralmente di che mangiare. Viveva compilando tesi universitarie. Non era capace di fare altro: era molto accurata nelle ricerche e scriveva bene. Mi ricordo che fece una tesi su Albertazzi e un'altra su Lorenzino de' Medici; me ne parlava continuamente. Quando ci siamo sposati, ho dovuto pagare le sue cambiali; neanche io avevo molti soldi e dovetti pensare a come guadagnarli.»
Elsa è una ragazza di famiglia modesta: la madre è maestra elementare, il padre istitutore in un riformatorio per minorenni. Collabora con giornali e riviste, non avendo completato gli studi in Lettere. Sin dall’inizio la loro è una relazione tormentata, segnata da allontanamenti e ritorni, comunicazione e distacco, bisogno di autonomia ed esigenza di affetto. Una maternità mancata, o non abbastanza voluta, è poi motivo di grande sofferenza per la giovane Elsa.
Straordinaria testimonianza di quegli anni è un suo diario, pubblicato postumo col nome di Diario 1938 (ma il titolo originale èLettere ad Antonio). Un “Libro dei sogni” che trascina nell’onirismo della giovane autrice ventiseienne, tra pensieri, ricordi e immagini da questi suscitati. Vi compaiono a più riprese allusioni a una figura maschile, A. (Moravia), e ad altre persone della famiglia: la madre, il padre, la sorella, i fratelli, alcuni amici. Al centro ci sono lei e le sue paure. Interrogativi, talvolta angosciosi, sull’infanzia, la maternità, l’erotismo, l’amore tormentato per A.
«Sonno interrotto e sogni confusi. Ricordo solo di aver sentito da casa squilli di campanelli lontani che mi chiamavano, e di aver percorso le scale drappeggiata in un lenzuolo e in una coperta, e così procedendo di aver incontrato un uomo piuttosto basso e pallido vestito di grigio. Sonno interrotto da telefonate di A., notte tutta piena di dolcissimi turbamenti lascivi. Mi atterrisce il domani incerto. Amo terribilmente A.»
«A. mi vuole bene – scrive nel 1938 all’amica Luisa Fantini - ma ogni tanto scappa via verso i più lontani paesi. Poi dice che bisogna finirla e poi mi prega di non finirla per carità. Ecc. Ora poi ho scoperto che io non sto stare al mondo e da quel momento siamo diventati una specie di favola perché in qualunque luogo e in mezzo a qualunque consesso rispettabile non finisce mai di farmi delle prediche e di arrabbiarsi a vuoto perché io al mondo non ci saprò mai stare. Vorrei, non so come dirti, fargli sentire delle parole bellissime, una musica tanto potente da riuscire a spiegargli che cosa è la vera bellezza della vita e del mondo. Lo vedo aggirarsi in quella sua specie di sotterraneo, agitarsi, dare schiaffi, annoiarsi e per quanto mi sforzi non riesco a portarlo via di là».
Il 14 aprile 1941, lunedì dell’Angelo, Moravia e Morante si sposano e si stabiliscono in un piccolo appartamento in via Sgambati, a Roma. Di lì a due anni saranno travolti dalle vicende belliche, che condizioneranno profondamente anche la loro produzione letteraria.
«Una mattina dopo l’8 settembre - scrive Moravia - un ungherese che presiedeva l’Associazione della Stampa estera mi disse: “Guardi che lei è nelle liste delle persone da arrestare”».
L’accusa è di antifascismo. Morante e Moravia lasciano così Roma per Napoli in fretta e furia ma restano bloccati dalle parti di Fondi: per sfuggire ai bombardamenti e alle retate s’inerpicano sulle montagne della Ciociaria, vivendo per otto mesi in una capanna dalle parti di Sant’Agata in compagnia di altri sfollati. Saranno liberati solo alla fine di maggio del ’44: a giugno rientrano nella capitale.
Gli otto mesi passati alla macchia lasciano un segno indelebile in entrambi. Moravia, anni dopo, ebbe a dire che due furono gli eventi che cambiarono significativamente la sua esistenza: la tubercolosi ossea contratta a nove anni e la guerra.
«Il signor Alberto – scrive Davide Marrocco, il contadino che ospitò la coppia a Fondi - tirava su l’acqua dalla cisterna. La signora Elsa cucinava, strapazzava le uova nella padella. “Alberto, Alberto tu sei quello che mangia di più”, gli diceva lei. Mia madre ogni mattina scaldava l’acqua per il bagno della signora Elsa e poi, durante la giornata, l’accudiva. La giornata del signor Alberto era questa. Alle sette di mattina saliva sulla montagna insieme a due o tre giovani sfollati, dove il pericolo d’essere intercettati dai tedeschi che perlustravano la zona era minore. Poi al tramonto tornavano alla capanna. Stava volentieri a parlare con gli altri sfollati, ma la maggior parte del tempo lo passava scrivere sui suoi quaderni. Si metteva dentro la baracca, a volte anche la signora Elsa gli faceva compagnia».
Dall’esperienza vissuta Moravia pubblicherà nel 1957 La Ciociara: sarà film nel ‘60 per la regia di Vittorio De Sica con Sophia Loren e Jean-Paul Belmondo e varrà alla Loren l’Oscar per la migliore attrice protagonista.
Dopo la guerra le condizioni economiche di Morante e Moravia vanno via via migliorando ed Elsa visita per la prima volta la Francia e l’Inghilterra. Il rapporto tra i due continua a essere tormentato.
«Le coppie di letterati sono una peste – scrive una trentaseienne Elsa, che ha appena concluso Menzogna e sortilegio, all’amica Maria Valli, moglie dell’editore dei racconti di Moravia. «Tu mi domandi dell'amore…Esso va male, nel senso che mi pare impossibile d'averlo mai provato e di poterlo provare ancora. Com'era? Che cos'era? Eppure mi sembrava d'esser tanto versata in questa materia, invece ho dimenticato tutto. In compenso il mio libro (Menzogna e sortilegio, nda) è pieno d'amore. Vorrei riposare e riposare e riposare, soffro di astenia e di esaurimento psichico fin nella radice dei capelli. Sono tormentata dai ricordi, dai rimorsi e dal futuro. Questo non vuol dire affatto che io sia infelice: forse basterebbe ch'io stessi un poco in alta montagna. Ho passato i tuoi saluti al “grande” Moravia (l'attributo è tuo, lo mettesti tu nella tua lettera, se ricordi - io te lo restituisco fedelmente)».
Nell’agosto 1948 Menzogna e Sortilegio vince il premio Viareggio. La coppia abbandona la casa degli scampati e acquista un attico nei pressi di Piazza del Popolo, in via dell’Oca, 27. Famoso e ricco, Moravia introduce la moglie nell'ambiente culturale romano, tra pittori, intellettuali e poeti. Ma Elsa, come dimostrano le sue lettere, sin dall'inizio vi si muove prima con grande imbarazzo poi con grande fastidio. Nonostante la sua insofferenza, sono anni di successo per entrambi: Moravia fonda la rivista Nuovi Argomenti, che sarà protagonista di numerosi dibattiti letterari, filosofici e politici. Morante, dopo il successo di Menzogna e Sortilegio, pubblica nel 1957 L’isola di Arturo, che vince il Premio Strega.
Nel gennaio 1961 partono entrambi con l’amico Pasolini in India: saranno a Calcutta, Bombay e nel sud del Paese. Di questo viaggio ci restano due reportage: Un’idea dell’India di Moravia, e L’Odore dell’India di Pasolini.
Intanto l’amore si sta consumando: dopo 26 anni di matrimonio, nel 1962, si lasciano definitivamente. Moravia conosce Dacia Maraini, che sarà la sua compagna fino al 1976 quando comincia a frequentarsi con Carmen LLera, di 45 anni più giovane di lui. Morante, dopo una breve relazione con il regista Luchino Visconti, conosce il pittore americano Bill Morrow a New York, che si suiciderà poco dopo. Non avrà più relazioni sentimentali.
«Forse tra noi due si era cristallizzata – dirà Moravia - una forma di rivalità psicologica. Ma è vero anche che non so neppure io quali sono stati i miei veri rapporti con Elsa. Mi sembra che sia stata lei a volerli troncare. Cioè, ho idea che abbia reso la nostra vita talmente difficile che sentivo che avrei rasentato la follia se non ci fossimo separati».
Elsa Morante muore a Roma nel 1985, sola e infelice.
«Ho appreso la morte di Elsa a Bonn, in Germania, dove mi trovavo in viaggio per un’inchiesta giornalistica. Era pieno inverno, aveva nevicato moltissimo. Allora sono uscito, ho camminato a lungo nella neve. Ero commosso e cercavo di dissipare la commozione con il gelo della giornata invernale. Tornai a Roma in tempo per il funerale, andai a vedere la salma esposta nella bara. Il viso di Elsa negli ultimi anni si era trasformato nel senso di una vecchiaia un po’ funesta. Con la morte era tornato a un aspetto quasi infantile, sereno, forse sorridente. Nella corsa del carro funebre i fiori, probabilmente male assicurati alla corona, volarono via uno dopo l’altro e andarono a schiacciarsi sull’asfalto: quei fiori che volavano via tra il carro funebre di Elsa e la mia macchina mi fecero un’impressione delirante e simbolica: così era volata via Elsa dalla mia vita».
Alberto Moravia muore a Roma nel 1990.