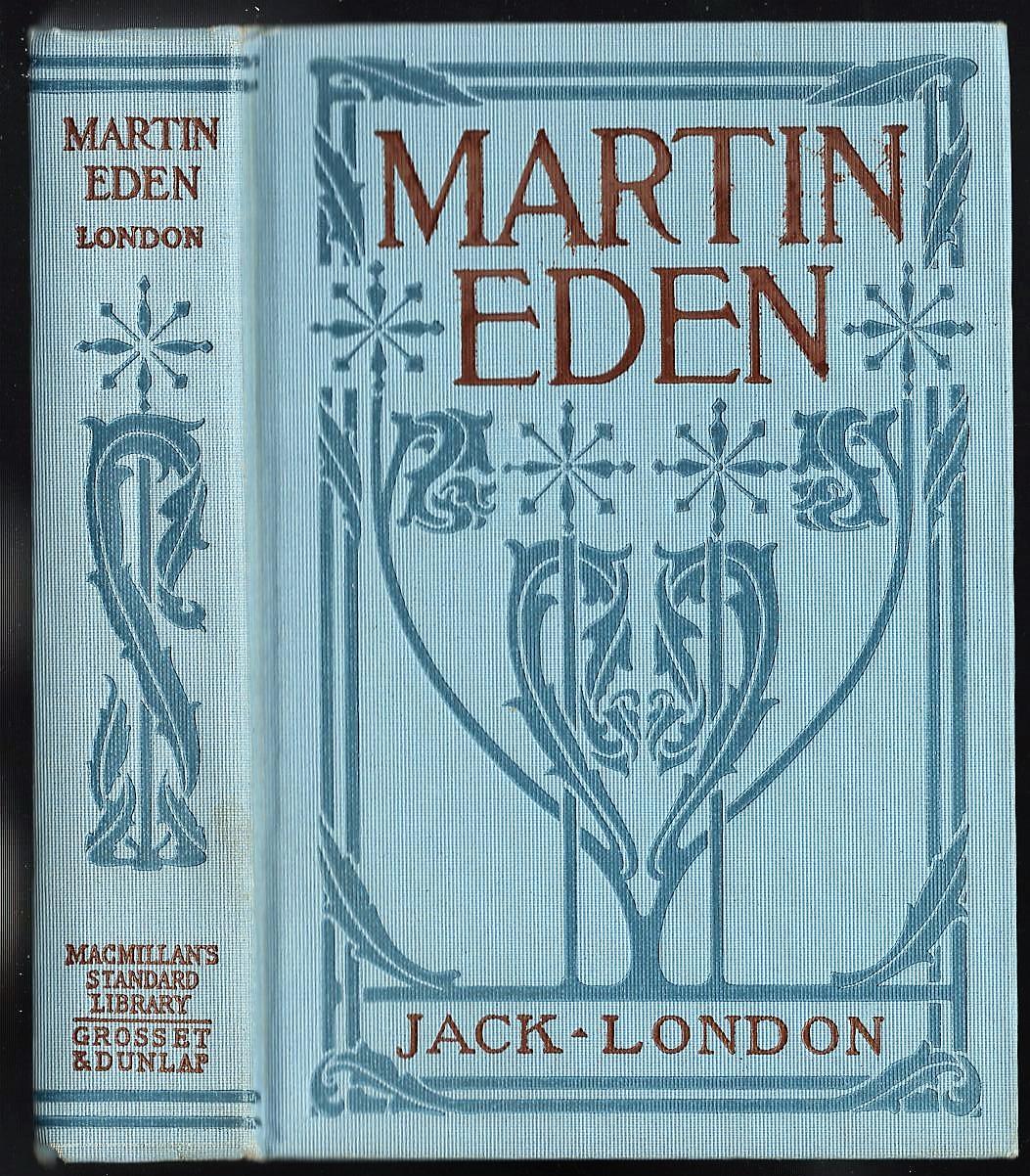
Jack London
MARTIN EDEN
XLI
Dormì pesantemente per tutta la notte, alzandosi solo all’arrivo del postino la mattina seguente. Si sentiva stanco e inerte e scorse la corrispondenza senza curiosità. Una busta speditagli da una rivista che di solito non pagava gli autori conteneva un assegno di ventidue dollari. Aveva sollecitato quel credito per un anno e mezzo. Osservò la cifra con indifferenza: non provava più alcuna emozione quando un editore pagava. A differenza dei precedenti, quell’assegno non recava con sé la promessa di un futuro luminoso. Era solo un foglio di carta del valore di ventidue dollari che gli avrebbe permesso di comprarsi qualcosa da mangiare.
Fra quel gruppo di lettere ce n’era una di un settimanale di New York contenente un altro assegno a saldo di alcune poesie comiche che erano state accettate qualche mese prima. Era di dieci dollari. Gli venne un’idea su cui rifletté con calma. Non sapeva che cosa avrebbe fatto in futuro e non aveva voglia di precipitarsi a fare alcunché, ma doveva pur vivere. E inoltre aveva numerosi debiti. Perché non investire parte di quei soldi nei francobolli occorrenti a spedire la massa dei manoscritti ammucchiati sotto il tavolo, rimettendoli in moto verso i vari editori? Un paio di accettazioni gli sarebbero servite a mantenersi per qualche tempo. Decise che valeva la pena di fare quell’investimento e dopo avere incassato gli assegni in una banca nel centro di Oakland comprò dieci dollari di francobolli. La prospettiva di tornare a casa a prepararsi da mangiare gli ripugnava. Per la prima volta si rifiutò di pensare ai debiti. Pur sapendo che in camera sua si sarebbe potuto preparare un pasto sostanzioso con un costo di quindici o venti centesimi, entrò nel Forum Café dove ordinò una colazione da due dollari, lasciando inoltre un quarto di dollaro di mancia al cameriere e spendendo altri cinquanta centesimi per un pacchetto di sigarette egiziane. Era la prima volta che fumava da quando Ruth gli aveva chiesto di smettere, ma ormai non capiva perché non avrebbe dovuto farlo e inoltre ne aveva una grande voglia. E perché preoccuparsi del denaro? Per cinque centesimi avrebbe potuto acquistare una confezione di tabacco Durham e cartine sufficienti ad arrotolarsi una quarantina di sigarette, ma a che pro? Ormai i soldi non avevano per lui altro valore che quello di consentirgli di comprare subito ciò che voleva. Era una nave priva di bussola e timone, e non aveva alcun porto da raggiungere: andare alla deriva comportava il minimo dispendio vitale, ed era proprio il vivere la cosa più dolorosa.
I giorni passavano e ogni notte dormiva regolarmente per otto ore. Pur costretto, in attesa di nuovi assegni, a frequentare ristoranti giapponesi dove si poteva mangiare con dieci centesimi, appariva ora ben nutrito e con le guance piene. Aveva detto basta ai sonni brevi, al superlavoro e allo studio frenetico. Non scriveva più nulla e aveva persino smesso di leggere. In compenso camminava molto sulle colline, o passeggiava senza meta per lunghe ore nella tranquillità dei parchi cittadini. Non aveva amici né conoscenti e non desiderava la compagnia di nessuno. Niente lo attraeva: aspettava che qualche stimolo, non sapeva di che natura, riuscisse a mettere in moto la sua esistenza. E nel frattempo la sua vita restava misera, priva di piani, vuota e oziosa.
Una volta andò a San Francisco per andare a trovare la «vera feccia», ma all’ultimo momento, dopo essere già arrivato sul pianerottolo, si arrestò e, girati i tacchi, fuggì, mescolandosi alla brulicante folla del quartiere. Era terrorizzato al pensiero di sentir parlare di filosofia e si allontanò con circospezione temendo di incontrare per caso qualcuno della «comune» e di essere riconosciuto.
Talvolta dava un’occhiata ai giornali e alle riviste per vedere che trattamento riservassero ad Effimera. Vide che aveva suscitato un grande clamore. Ma che clamore! Lo avevano letto tutti e dappertutto si discuteva se fosse o non fosse vera poesia. Se ne scriveva persino nei giornali locali e quotidianamente comparivano colonne e colonne di critiche erudite, di editoriali faceti e di corrispondenza dei lettori. Helen Della Delmar (proclamata con suono di fanfare e rullio di tamburi la più grande poetessa degli Stati Uniti) dichiarò che Brissenden non meritava un posto accanto a lei sul Parnaso e scrisse lunghe lettere aperte per dimostrare che non era un poeta.
Nel numero seguente «The Parthenon» si autoincensava per il successo riportato e ironizzava pesantemente su Sir John Value, sfruttando la morte di Brissenden a fini bassamente commerciali. Un giornale che dichiarava una tiratura di mezzo milione di copie pubblicò una poesia originale e spontanea di Helen Della Delmar, in cui l’autrice attaccava velenosamente Brissenden, da lei poi parodiato in un secondo poemetto.
Più volte Martin dovette ammettere di essere contento che Brissenden fosse morto. Lui aveva tanto detestato la folla ed ecco qui le sue cose più belle e più sacre date in pasto alle masse. Ogni giorno si vivisezionava la Bellezza. Tutte le teste vuote del paese si affrettarono a scrivere alla stampa riuscendo a soddisfare la propria meschina vanità sull’onda della grandezza di Brissenden. Un giornale disse: «Abbiamo ricevuto la lettera di un signore che tempo fa scrisse una poesia simile, ma migliore». Un altro, disapprovando la parodia di Helen Della Delmar, affermò in tutta serietà: «Non c’è dubbio che la signorina Delmar l’abbia scritta in un momento di leggerezza e senza il rispetto che un grande poeta deve nutrire nei confronti di un altro grande poeta, forse il più grande di tutti. E tuttavia, che lo abbia fatto o no per gelosia verso l’autore di Effimera, è evidente che ella, come migliaia di altre persone, è affascinata da quest’opera e che magari un giorno cercherà di scrivere versi come questi».
Nelle chiese i preti cominciarono a tuonare contro Effimera, e un predicatore che ne difese ostinatamente il contenuto fu espulso per eresia. Anche la letteratura umoristica se ne impadronì. Strofette comiche e caricature fecero sbellicare la gente dalle risa, mentre nelle rubriche dei settimanali mondani si stampavano barzellette come quella in cui Charley Frensham diceva in confidenza ad Archie Jennings che cinque versi di Effimera avrebbero spinto un uomo a picchiare un paralitico, e dieci ad affogarsi nel fiume.
Questo grande schiamazzo non provocò in Martin né divertimento, né indignazione, ma solo una profonda tristezza. Davanti al crollo di tutto il suo mondo, di cui l’amore era il supremo pinnacolo, la scoperta che nella stampa periodica e nel grosso pubblico vi fossero tali abissi di stupida e volgare superficialità lo lasciava quasi indifferente. Brissenden aveva perfettamente ragione nel dare di quell’ambiente il giudizio severo cui lui, Martin, era giunto solo ora, dopo anni di fatiche tremende e inutili. Le riviste erano proprio ciò che Brissenden diceva, e lo consolava il pensiero di aver chiuso con loro. Aveva seguito la luce di una stella e si era ritrovato fra i miasmi di una palude. Sempre più spesso gli tornavano alla mente le visioni di Tahiti – la dolce e pura Tahiti – e delle piatte Paumotu e delle alte Marchesi; e rivedeva se stesso a bordo di golette mercantili o di fragili lance che scivolavano all’alba attraverso la barriera di Papeete per cominciare la lunga navigazione fra le isole delle perle fino a Nukahiva e alla Baia di Taiohae, dove Tamari, lo sapeva, avrebbe ucciso un maiale per festeggiare il suo arrivo e le ragazze con le collane di fiori l’avrebbero preso per mano cantando e gli avrebbero messo le ghirlande al collo. I Mari del Sud lo chiamavano, e Martin sapeva che presto o tardi avrebbe risposto al richiamo.
Nel frattempo si lasciava trascinare passivamente dagli eventi: sentiva il bisogno di fermarsi a riprendere fiato dopo il lungo e arduo viaggio che aveva fatto attraverso il regno della conoscenza. Quando gli arrivò l’assegno di trecentocinquanta dollari del «Parthenon», lo girò al legale della città che aveva curato gli affari di Brissenden per conto della famiglia. Nell’occasione si fece rilasciare una ricevuta e gli diede a sua volta un pagherò per i cento dollari anticipatigli dall’amico.
Non molto tempo dopo Martin cessò di frequentare i ristoranti giapponesi. La fortuna aveva cominciato a sorridergli proprio quando aveva abbandonato la lotta. Ma ormai era troppo tardi. Aperta la busta speditagli dal «Millennium» vi trovò dentro, senza che ciò provocasse in lui alcun brivido di emozione, un assegno di trecento dollari per Avventura, che gli veniva dunque pagato al momento stesso dell’accettazione. La somma totale dei debiti che aveva, compreso quello presso il banco dei pegni con i suoi interessi di usura, ammontava a meno di cento dollari. Saldata ogni pendenza e ritirato l’effetto in possesso dell’avvocato di Brissenden, si ritrovò con più di cento dollari in tasca. Si fece fare un abito da un sarto e prese a mangiare nei migliori ristoranti cittadini. Continuò a tenere la stanzetta nella casa di Maria, ma alla vista del bel vestito che indossava i ragazzi del rione smisero di gridargli «vagabondo» e «barbone» nascosti sui tetti delle rimesse e dietro gli steccati.
Il racconto hawaiano Wiki-Wiki fu acquistato dal «Warren Monthly» per duecentocinquanta dollari, mentre il saggio La culla della bellezza fu accettato dalla «Northern Review» e La chiromante, la poesia che aveva scritto per Marian, dal «Mackintosh’s Magazine». I direttori e i consulenti erano tornati dalle vacanze estive, e ciò giustificava quel risveglio di interesse per i suoi manoscritti. Tuttavia Martin non riusciva a capire per quale capriccio fossero ora spinti ad assicurarsi le opere che per due anni avevano continuato a rifiutare. Nulla di suo era stato pubblicato, il suo nome era ignoto al di fuori di Oakland e nella sua città i pochi che pensavano di conoscerlo lo consideravano un sovversivo socialista. Niente spiegava questa grande attenzione per i prodotti del suo ingegno. Era un puro e semplice scherzo del destino.
Poiché La vergogna del sole era stato respinto da alcune riviste, aveva deciso, seguendo il consiglio di Brissenden, di offrirlo a case editrici di libri e, dopo diversi rifiuti, era stato accettato dalla Singletree, Darnley & Co., con promessa di pubblicazione in autunno. Alla richiesta di un anticipo sui diritti d’autore, gli risposero che non era loro abitudine concederlo, tanto più che opere di quel genere raramente coprivano le spese e il suo libro difficilmente sarebbe arrivato a vendere mille copie. Martin calcolò quale sarebbe stato il suo compenso in tale eventualità. Con una percentuale del quindici per cento su un prezzo di copertina di un dollaro, il guadagno sarebbe stato di centocinquanta dollari. Decise dunque che se avesse ripreso a scrivere si sarebbe dedicato esclusivamente alla narrativa. La pubblicazione di Avventura sulla rivista «The Millennium» gli aveva fruttato il doppio, benché il racconto fosse un quarto della lunghezza del saggio. Dopo tutto, ciò che aveva letto su un giornale tanto tempo prima era esatto: i periodici di prim’ordine pagavano all’accettazione e prevedevano compensi elevati. «The Millennium» gli aveva concesso ancor più di due centesimi a parola: gliene aveva dati quattro. Inoltre ciò che stampava era di grande qualità. Non si era appena assicurato i suoi scritti? Quest’ultima riflessione lo fece sogghignare.
Scrisse alla Singletree, Darnley & Co. offrendo loro i diritti di pubblicazione dell’opera per la somma forfettaria di cento dollari, ma l’editore non accettò il rischio. Ciò non lo preoccupò. Ormai non aveva più problemi economici, perché parecchi dei suoi racconti più maturi erano stati stampati e pagati. Arrivò ad aprire un conto in banca con un deposito di parecchie centinaia di dollari, e ciò dopo avere saldato tutti i debiti. Dopo che fu rifiutato da parecchie riviste, Scaduto fu accettato dalla casa editrice Meredith-Lowell Company. Ricordandosi dei cinque dollari che Gertrude gli aveva dato e della promessa di restituirglieli moltiplicati per cento Martin scrisse all’editore chiedendo un anticipo di cinquecento dollari sui diritti d’autore. Con sua grande sorpresa ricevette, a stretto giro di posta, un assegno per tale cifra allegato al contratto di pubblicazione. Dopo averne incassato l’importo, che si fece versare in monete d’oro da cinque dollari, telefonò a Gertrude chiedendole di venire da lui.
La sorella arrivò subito, ansimando per la gran corsa che aveva fatto. Sospettando una richiesta di denaro aveva ficcato nella borsa i pochi dollari che possedeva; ed era così sicura che il fratello fosse ormai nella più nera miseria che nel vederlo gli si buttò fra le braccia singhiozzando e mettendogli i soldi in mano senza parlare.
«Sarei venuto io», disse Martin, «ma non volevo incontrare tuo marito, perché avremmo certamente litigato».
«Fra un po’ gli passerà», lo rassicurò lei, chiedendosi in che guaio si fosse cacciato Martin questa volta. «Ma tu dovresti trovarti un posto e sistemarti. Quelli che hanno un lavoro per bene gli piacciono. Quella storia dei giornali lo ha sconvolto. Non l’ho mai visto così arrabbiato».
«Non ho intenzione di trovarmi un posto», rispose Martin con un sorriso. «Puoi dirglielo da parte mia. Non ne ho bisogno, ed eccotene la prova».
Le versò in grembo i cento scintillanti pezzi d’oro, che cadendo tintinnarono.
«Ricordi quel «cinque» che mi hai dato un giorno in cui non avevo i soldi del tram? Eccolo qua, te lo restituisco con altri novantanove fratelli tutti uguali a lui».
Se arrivando Gertrude era spaventata, ora fu presa da un panico tale che il sospetto divenne certezza. Annientata da quella rivelazione fissò Martin terrorizzata e come schiacciata dal peso dell’oro maledetto, da cui si ritrasse inorridita.
«È tuo», rise lui.
Gertrude scoppiò in lacrime e cominciò a gemere: «Mio povero ragazzo, mio povero ragazzo!».
Dopo qualche attimo di perplessità, egli indovinò la causa di tanta agitazione e le porse subito la lettera di accompagnamento dell’assegno della Meredith-Lowell. La lesse con difficoltà, fermandosi di tanto in tanto per asciugarsi gli occhi, e quando ebbe finito disse:
«Vuol dire che questi soldi ti sono arrivati in modo onesto?».
«Sono più onesti che se li avessi vinti alla lotteria, perché me li sono guadagnati».
A poco a poco la sorella riacquistò la fiducia, e rilesse la lettera con attenzione. Gli ci volle non poco per spiegarle la natura dell’operazione che lo aveva portato a ricevere quel denaro, e ancor più per farle capire che era proprio suo perché lui non ne aveva bisogno.
«Lo metterò in banca per te», disse lei infine.
«Non farai nulla del genere. È tuo e usalo come vuoi. Se non lo vuoi lo darò a Maria, che invece sa bene che cosa farne. Ti consiglio, però, di assumere una domestica, e di riposarti per un bel po’».
«Lo voglio dire a Bernard», dichiarò Gertrude andandosene.
Martin fece una smorfia, poi sogghignò.
«Sì, fallo pure», disse. «Magari ricomincerà ad invitarmi a cena».
«Oh, sì… ne sono sicura!», esclamò lei con fervore attirandolo a sé per abbracciarlo e baciarlo.
XLII
Un giorno Martin si accorse di sentirsi solo. Pur essendo pieno di salute e di forza non aveva nulla da fare. La cessazione da ogni attività letteraria, la morte di Brissenden e la rottura con Ruth avevano aperto in lui un grande vuoto, che non poteva essere colmato dai cibi raffinati nei ristoranti di lusso e dall’aroma del tabacco egiziano. C’era il richiamo dei Mari del Sud, era vero, ma sentiva che gli restava ancora molto da fare negli Stati Uniti. Presto sarebbero comparsi due libri suoi e ne aveva altri che potevano trovare un editore. In questo modo avrebbe potuto fare parecchi soldi. Avrebbe dunque atteso di avere un bel gruzzolo prima di partire per le isole felici. Nelle Marchesi ricordava un terreno in riva al mare che avrebbe potuto avere per mille dollari cileni. Era una valle di forse quattromila ettari, delimitata, dalla parte della costa, da una baia a ferro di cavallo e, verso l’entroterra, dalle cime di ripidi picchi incappucciati di nuvole. Era piena di frutti tropicali, di uccelli selvatici e di cinghiali e percorsa da branchi di bovini bradi, mentre fra le balze delle alture i cani selvatici davano la caccia alle capre di montagna. Era un territorio rimasto disabitato, allo stato naturale, che si poteva comprare, insieme con la rada, per mille dollari cileni.
Per quanto se ne ricordava, la baia era magnifica, con fondali tanto alti che potevano penetrarvi le navi più grandi, e così sicura che la Guida Marittima del Sud Pacifico la raccomandava come il posto migliore che l’oceano potesse offrire in un raggio di diverse miglia per il carenaggio delle navi. Avrebbe comprato una goletta – una di quelle imbarcazioni simili ai panfili e rivestite di rame che filavano come frecce, con la quale avrebbe girato le isole smerciando copra e pescando perle. Di quella valle e di quella baia avrebbe fatto il suo quartier generale. Avrebbe costruito una casa patriarcale di zolle d’erba come quella di Tati e l’avrebbe riempita, come la goletta e la valle, di uomini di pelle scura a lui legati. Vi avrebbe invitato il fattore di Taiohae, i comandanti dei mercantili di passaggio e tutti i migliori esemplari della marmaglia che pullulava nel Sud Pacifico. Avrebbe avuto la casa sempre aperta e avrebbe ricevuto come un principe. In questo luogo avrebbe dimenticato i libri che aveva letto e il mondo che si era dimostrato illusorio.
Per poter realizzare tutto ciò sarebbe dovuto restare in California fino a quando non si fosse esaurito il filone d’oro che aveva appena scoperto. Se uno dei suoi libri avesse avuto successo sarebbe riuscito a vendere tutto il mucchio dei manoscritti. Per potersi assicurare la rada, la valle e la goletta, avrebbe anche raccolto in volume tutti i racconti e tutte le poesie, ma non avrebbe scritto più nulla, questo era certo. Nel frattempo, nell’attesa di realizzare tutto ciò, doveva fare qualcosa di meglio che continuare a vivere in quella specie di inerzia confusa e indifferente in cui era precipitato.
Una domenica mattina apprese che quel giorno ci sarebbe stato il Picnic dei muratori allo Shell Mound Park, e decise di andarci. Era stato troppe volte a queste sagre della classe operaia per non sapere come fossero e, all’ingresso del parco, riprovò tutte le sensazioni di un tempo. In fin dei conti erano persone del suo ceto, questi proletari. Fra loro era nato, fra loro era vissuto e fra loro era contento di tornare dopo esserne rimasto lontano per un certo periodo.
«Guarda, guarda chi si vede! Mart!», udì dire da qualcuno e subito sentì una mano che gli batteva cordialmente sulla spalla. «Dove sei stato tutto questo tempo? Sei stato in mare? Su, vieni a bere con noi».
Ritrovò la compagnia di allora – i vecchi amici, con qualche vuoto qua e là e alcune facce nuove. Non erano muratori, ma come ai vecchi tempi, andavano a tutte le feste all’aperto per ballare, divertirsi e fare a botte. Martin bevve con loro e ricominciò a sentirsi come un essere umano. Era stato uno sciocco ad abbandonarli, pensò; aveva la certezza che sarebbe stato più felice se fosse rimasto con loro invece di rincorrere i libri e la gente che occupava alte posizioni. E tuttavia la birra non gli pareva buona come allora. Concluse che era stato Brissenden a rovinargli il gusto e si chiese se, dopo tutto, i libri non lo avessero guastato al punto che non sapeva più apprezzare la compagnia degli amici di gioventù. Decise che non doveva mostrarsi schifiltoso e andò alla pista da ballo. Vi incontrò Jimmy, l’idraulico, insieme con una ragazza alta e bionda che immediatamente lo abbandonò per Martin.
«Perdinci, come ai vecchi tempi», osservò Jimmy rivolto agli altri che presero a sbeffeggiarlo mentre Martin roteava con la bionda in un giro di valzer. «Ma non me ne importa un accidente. Sono così contento che è tornato. Guardatelo come balla. È leggero come una piuma. Bisogna capirle, le ragazze».
Tuttavia Martin riportò la bionda a Jimmy e tutti e tre, insieme con altri cinque o sei della banda, si soffermarono a ridere, a scherzare e a guardare le coppie che piroettavano nella danza. Tutti erano felici che fosse tornato Martin. Non essendo ancora uscito alcuno dei suoi libri non era ricercato per il suo prestigio, ma apprezzato per ciò che era. Si sentiva come un principe tornato dall’esilio, la cui gelida solitudine si scioglieva al calore della simpatia che lo circondava. Fu una giornata indimenticabile, in cui egli diede il meglio di sé. Aveva in tasca parecchio denaro e lo spese generosamente, come nel passato quando sbarcava con i soldi della paga.
Una volta, sulla pista da ballo, vide passare Lizzie Connolly fra le braccia di un giovane operaio, e più tardi, girando sotto il tendone, la ritrovò seduta a uno dei tavolini. Dopo le espressioni di sorpresa e i convenevoli, andò a passeggiare con lei fra i vialetti del parco dove era possibile parlare senza dover alzare la voce per via della musica. Da questo momento egli capì che era sua. Lei lo palesava nell’orgogliosa modestia dello sguardo, nei dolci movimenti di quel corpo fiero e nel modo in cui pendeva dalle sue labbra. Non era più la fanciulla che aveva conosciuto tempo fa. Era una donna, e Martin notò che la sua bellezza selvaggia e insolente si era affinata, e pur non perdendo nulla della propria genuinità, aveva leggermente attenuato la sua natura focosa e provocatoria. «Una bellezza, una bellezza perfetta», mormorò lui sotto voce. Capì che era sua e gli sarebbe bastato dirle «Vieni» perché lo seguisse in capo al mondo.
E nell’istante in cui quel pensiero gli balenò nel cervello, venne colpito alla tempia da un colpo che per poco non lo fece crollare a terra. Gli era stato sferrato da un uomo così fuori di sé per la rabbia da mancare la mascella, cui era diretto. Martin si voltò traballando e vide arrivargli addosso una sventola terribile. Si scansò quasi istintivamente e il pugno lo sfiorò innocuo, facendo ruotare su se stesso il suo avversario. Martin replicò con un gancio sinistro sferrato con tutto il peso del corpo. L’uomo, già sbilanciato per il colpo andato a vuoto, cadde al suolo su un fianco, ma subito rialzatosi gli si avventò contro. Scorgendo quei lineamenti alterati dalla rabbia Martin si chiese da che cosa nascesse tanta collera, ma mentre rifletteva scagliò un diretto sinistro, accompagnato anche questa volta dal movimento di tutto il corpo. L’altro indietreggiò e crollò riverso. Jimmy e tutti gli altri della compagnia corsero verso di loro.
Martin era tutto eccitato. Era proprio come ai vecchi tempi, con i balli, le risse e i divertimenti. Pur senza perdere d’occhio l’avversario, lanciò uno sguardo a Lizzie. Di solito le ragazze strillavano quando gli uomini facevano a botte, ma lei era rimasta ferma e immobile a guardare con il fiato sospeso, la figura leggermente inclinata in avanti, attratta da ciò che vedeva, una mano al petto, le guance animate e una grande e stupita ammirazione negli occhi.
L’uomo si era rialzato e stava divincolandosi per liberarsi dalle braccia che lo tenevano.
«Lei stava aspettando che tornavo», esclamò rivolto a tutti i presenti. «Stava aspettando che tornavo ed ecco che arriva questo a mettersi in mezzo. Lasciatemi andare, per dio. Adesso lo sistemo per le feste».
«Stai fermo se vuoi restare tutto intero», gli disse Jimmy trattenendolo insieme con gli altri. «Quello lì è Mart Eden. È un diavolo con i pugni, ficcatelo bene in testa. È capace di farti a pezzi se gli fai venire la mosca al naso».
«Ma non può fregarmela così», ribatté l’altro.
«Le ha date all’Olandese volante», continuò animatamente Jimmy. «L’ha liquidato in meno di cinque riprese. Contro di lui non resti in piedi un minuto. Chiaro?».
Questa informazione parve avere un effetto calmante sull’ira dell’uomo, che soppesò Martin con lo sguardo.
«Non si direbbe», disse in tono di scherno ma senza aggressività.
«Lo pensava anche l’Olandese volante», lo assicurò Jimmy.
«Su, dacci un taglio. Ci sono un sacco di altre ragazze in giro».
Il giovane si lasciò condurre verso il tendone, seguito dagli altri della compagnia.
«Chi è?», chiese Martin a Lizzie. «E poi, perché tutto questo can-can?».
L’eccitazione della lotta, che in passato era acuta e duratura, era già svanita, ed egli si accorse di essere così portato all’autoanalisi che gli era ormai impossibile vivere in modo tanto primitivo, con cuore semplice e mano lesta.
Lizzie scosse il capo.
«Oh, non è nessuno», disse. «È solo un tale con cui stavo».
«Ho dovuto», aggiunse dopo una pausa. «Mi sentivo molto sola. Ma non ho mai dimenticato». Abbassando la voce guardò fisso davanti a sé. «Non ci avrei pensato un attimo a lasciarlo per te».
Osservando quel viso rivolto altrove con la sicurezza che gli sarebbe bastato un cenno per averla, Martin cominciò a chiedersi se dopo tutto ci fossero sentimenti veri dietro le belle forme e il parlare forbito, e immerso in questa riflessione tardò a risponderle.
«L’hai fatto volare», disse lei con una risata, non sapendo che pensare di quel silenzio.
«È un tipo tosto, però», ammise lui generosamente. «Se non l’avessero portato via sarebbe stato un osso duro».
«Chi era quella signora con cui ti ho visto quella sera?», chiese lei all’improvviso.
«Oh, solo un’amica».
«È stato tanto tempo fa», mormorò lei con tono riflessivo. «Pare un secolo».
Ma Martin lasciò perdere quell’argomento e indirizzò altrove la conversazione. Pranzarono al ristorante, dove egli ordinò vino e altre costose prelibatezze, e poi, tornati al ballo, danzò con lei e con nessun’altra fino a quando Lizzie non fu stanca. Era un buon ballerino, e girando fra le sue braccia in un’estasi di felicità, con la testa appoggiata sulla sua spalla, lei avrebbe voluto che quel momento durasse all’infinito. Più tardi, nel corso del pomeriggio, passeggiarono fra gli alberi, sotto i quali, come ai bei tempi, lei si sedette, mentre Martin sdraiato supino, le teneva la testa in grembo. Rimasero così, lui assopito e lei chinata ad accarezzargli i capelli, a contemplare i suoi occhi chiusi e ad amarlo con tutta l’anima. Aprendo le palpebre all’improvviso lui capì dalla sua espressione intenerita quel che lei provava. Lizzie socchiuse gli occhi, quindi li spalancò, fissandoli in quelli di lui con uno sguardo pieno di dolcezza e di sfida.
«Mi sono comportata bene tutti questi anni», disse, con voce così bassa che era quasi un bisbiglio.
Martin comprese che quella era la miracolosa verità, e in cuor suo provò la grande tentazione di renderla felice. Doveva forse rifiutarle questa possibilità solo perché a lui era ormai negata? Avrebbe potuto sposarla e portarla a vivere con sé nel castello di zolle d’erba alle isole Marchesi. Ma per quanto forte fosse quel desiderio, ancor più forte fu l’imperativo di non farlo. Nonostante tutto rimaneva fedele all’Amore. Com’erano lontani i giorni della licenza e delle facili avventure! Non poteva né tornarvi, né richiamarli a sé. Sapeva di essere cambiato, ma non avrebbe mai creduto di esserlo a tal punto.
«Non sono tipo da sposarmi, Lizzie», disse piano.
La mano che gli carezzava i capelli si fermò per un istante prima di riprendere quel dolce movimento. Martin notò che il viso di lei si era indurito nella risolutezza, pur senza perdere nulla del caldo colore delle guance e della commossa dolcezza dei lineamenti.
«Non volevo dire questo…», aggiunse senza finire la frase. «Comunque non m’importa. Non m’importa», ripeté. «Sono orgogliosa di essere la tua amica. Per te sono pronta a qualunque cosa. Sono fatta così».
Martin si rizzò a sedere e le prese la mano. Lo fece deliberatamente, con un calore senza passione che le diede un brivido di freddo.
«Sei una donna grande e nobile», le disse, «e sono io che devo essere orgoglioso di conoscerti. E lo sono davvero. Tu per me sei un raggio di luce in questo mondo di tenebre, e io ho il dovere di essere leale con te come tu lo sei stata con me».
«Non m’importa se tu sei leale con me o no. Di me puoi fare qualunque cosa. Puoi gettarmi nel fango e camminarmi sopra. Sei l’unico uomo al mondo che può», aggiunse con aria di sfida. «Non per nulla è da quando sono bambina che bado a me stessa».
«Ed è proprio per questo che non voglio farlo», disse lui dolcemente. «Sei così brava e generosa che non posso esserti da meno. Non voglio sposarmi e… non voglio fare all’amore con te senza sposarti, anche se queste cose le ho fatte in passato. Mi dispiace di essere venuto qui oggi e di averti incontrato. Ma ormai non c’è rimedio, anche se non pensavo che le cose andassero così.
«Ascoltami Lizzie. Non so dirti quanto tu mi stia a cuore, o meglio, quanto ti ammiri e ti rispetti. Tu sei buona, sei meravigliosa. Ma a che servono le parole? C’è qualcosa che vorrei fare per te. Hai avuto un’esistenza difficile. Permettimi di darti un aiuto». (Negli occhi le balenò un lampo di gioia che presto si spense). «Ho la certezza che presto mi arriveranno dei soldi… molti soldi».
Fu allora che abbandonò l’idea della valle e della baia, del castello di zolle d’erba e della bella goletta bianca. Dopo tutto era una cosa senza importanza. Poteva fuggire, come aveva fatto tante volte prima di allora, come semplice marinaio, su una nave qualsiasi, diretta in un posto qualsiasi.
«Vorrei darli a te. Ci dev’essere qualcosa che ti piacerebbe fare – frequentare una scuola o un istituto commerciale. O magari studiare per diventare stenografa. Posso pensarci io. O forse tuo padre e tua madre sono ancora in vita… potrei aprir loro una drogheria o qualcosa del genere. Qualunque cosa tu voglia non hai che da dirmela e io la farò».
Lizzie non rispose. Rimase seduta, immobile, gli occhi fissi davanti a sé, ma con una voglia di piangere così forte che anche Martin sentì un groppo in gola e si pentì di aver parlato. Gli parve così meschino quello che le aveva offerto – denaro – rispetto a quanto gli avrebbe dato lei. Lui le concedeva qualcosa di estraneo, di cui poteva liberarsi senza ambascia, ma lei gli donava tutta se stessa, senza preoccuparsi del disonore, dell’onta, del peccato e della perdita della grazia.
«Non parliamone», disse lei con una voce incrinata che mascherò in un accesso di tosse. Si rizzò in piedi. «Su, torniamo a casa. Sono stanchissima».
La giornata era finita e quelli che erano venuti per la festa se n’erano andati quasi tutti, ma quando uscirono dagli alberi videro che gli altri li stavano aspettando. Martin capì subito che cosa stava avvenendo: si preparavano disordini e gli amici facevano loro da guardia del corpo. Passarono infatti i cancelli del parco seguiti da un gruppo di giovanotti che il ragazzo di Lizzie aveva chiamato a raccolta per vendicare la perdita della sua donna. Prevedendo una rissa diversi vigili e agenti di polizia di reparti speciali erano intervenuti per prevenirla riuscendo a incanalare le due bande in punti separati del treno diretto a San Francisco. Martin disse a Jimmy che sarebbe sceso alla fermata della Sedicesima Strada per prendere il tram per Oakland. Lizzie rimase tranquilla, disinteressata a ciò che si stava verificando. Quando il treno si fermò, la vettura era già in attesa e il tranviere stava scampanellando con impazienza.
«Eccolo lì», esclamò Jimmy. «Fai una corsa e noi li tratteniamo. Vai ora! Saltagli su!».
La banda rivale fu per un attimo sconcertata da quella manovra; quindi si precipitò dal treno all’inseguimento. I sobri e posati passeggeri di Oakland seduti nella vettura notarono appena il giovanotto e la ragazza che arrivando di corsa trovarono due posti nella parte anteriore dell’imperiale e non collegarono la coppia con Jimmy, che balzando sul predellino urlò al conducente: «Forza con la manetta, vecchio mio, schizza via di qua!».
Subito dopo Jimmy si girò di scatto e i passeggeri lo videro sferrare un pugno sulla faccia di un uomo che correndo stava cercando di salire sul tram. Subito una tempesta di botte e di colpi partì dai lunghi predellini ai lati della vettura, che Jimmy e la sua banda riuscirono ad occupare prima dell’arrivo del nemico. Il tram partì in un furioso scampanellio, mentre la banda di Jimmy, respinti gli ultimi assalitori, saltava a terra per completare l’opera. Accelerando di colpo, il tranviere si lasciò indietro tutto quello scompiglio, con sollievo degli esterrefatti passeggeri, i quali non avrebbero mai immaginato che il quieto giovanotto e la graziosa operaia seduti in un angolo dell’imperiale fossero la causa di tanto sconquasso.
Martin si era esaltato nella battaglia, durante la quale aveva risentito le vecchie emozioni, ma queste erano presto sparite in un’opprimente, infinita tristezza. Si sentì vecchio – molto più vecchio di quei giovani spensierati e noncuranti, antichi compagni della sua vita passata. Era andato lontano, troppo lontano per tornare. I loro modi, che una volta erano stati anche i suoi, ora lo disgustavano. Quella delusione gli aveva fatto capire di essere diverso da loro. La loro compagnia gli era parsa aspra, proprio come il sapore della loro birra. Le migliaia di libri che aveva letto avevano scavato fra loro un abisso. Si era condannato all’esilio. Il viaggio nel regno dell’intelletto lo aveva portato così in là che il ritorno gli era impossibile. Il suo bisogno di contatti umani, la sua ardente brama di compagnia rimanevano inappagati. Non aveva trovato una nuova patria. Non lo capivano gli amici di un tempo, non lo capiva la famiglia, non lo capiva la borghesia, e neppure la ragazza accanto a lui, per la quale egli aveva un grande rispetto, era in grado di capirlo e di comprendere la nobiltà del suo comportamento. Queste riflessioni aggiunsero amarezza alla tristezza.
«Fa’ pace con lui», consigliò a Lizzie al momento dell’addio, davanti alla povera casa in cui abitava, nei pressi di Market Street e della Sesta. Si riferiva al giovanotto di cui quel giorno aveva usurpato il posto.
«Non posso… adesso», rispose lei.
«Oh, andiamo», disse in tono scherzoso. «Ti basta fare un fischio e lui verrà di corsa».
«Non intendevo questo», rispose lei semplicemente.
E lui capì che cosa aveva voluto dire.
Mentre le stava augurando la buona notte, Lizzie si chinò verso di lui; lo fece senza malizia né iattanza, ma con aria umile e mesta. Ne fu toccato e sentì dentro di sé un impeto di grande generosità. L’avvolse con le braccia e nel baciarla capì che il bacio che riceveva era il più sincero che un uomo avesse mai ricevuto da una donna.
«Mio Dio!», disse lei singhiozzando. «Potrei morire per te. Potrei morire per te».
Poi si strappò a quella stretta e salì di corsa i gradini. Martin si sentiva gli occhi umidi.
«Martin Eden», disse fra sé. «Non sei un bruto, e come nietzschiano vali poco. Se potessi la sposeresti, e riempiresti di felicità il suo cuore palpitante. Ma non puoi, non puoi. Ed è una gran vergogna.
«”Un povero vecchio vagabondo racconta le sue vecchie piaghe”», mormorò citando Henley. «”La vita, per me, è un vergognoso errore”. E lo è, un vergognoso errore».
XLIII
La vergogna del sole fu pubblicato in ottobre. Nel tagliare le corde del pacco e nello spargere sul tavolo le cinque o sei copie omaggio che l’editore gli aveva mandato, Martin sentì una grande tristezza. Pensando all’irrefrenabile gioia che avrebbe provato se ciò fosse avvenuto solo qualche mese prima, la confrontò con l’accidiosa freddezza che lo aveva invaso. Davanti al suo libro, il suo primo libro, non era emozionato, ma solo depresso. Esso non gli diceva nulla, ora. Al massimo gli avrebbe fruttato un po’ di denaro, a cui, del resto era abbastanza indifferente.
Presa una copia, andò in cucina per regalarla a Maria.
«L’ho fatto io», disse in risposta alla sua aria sbalordita. «L’ho scritto in quella camera e credo proprio di essere stato tenuto su da qualche scodella della tua zuppa di verdura mentre lo facevo. Te lo do. È tuo. Così mi ricorderai».
Non lo disse per impressionarla, per mettersi in mostra davanti ai suoi occhi, ma solo per renderla felice, per far sì che si sentisse orgogliosa della sua opera, per mostrarle riconoscenza della fede che aveva avuto in lui. Lei mise il volume nella stanza buona, sopra la Bibbia di famiglia. Era un oggetto sacro, quel libro fatto dal suo inquilino, un simbolo di amicizia, che attenuò il disonore di Martin di essere stato lavandaio. Capiva, pur non comprendendone una sola riga, che era una cosa grande. Era una donna semplice, pratica, lavoratrice, ma piena di fede.
Con la stessa indifferenza con cui aveva ricevuto le copie della Vergogna del sole, lesse le recensioni che settimanalmente gli faceva pervenire l’ufficio stampa. Il libro aveva colto nel segno, questo era evidente, e ciò voleva dire altro oro nella borsa. Dopo avere sistemato Lizzie e mantenuto tutte le promesse gli sarebbe ancora rimasta una cifra sufficiente a costruire il vagheggiato castello di foglie d’erba.
Per prudenza la Singletree, Darnley & Co. aveva stampato inizialmente solo millecinquecento copie, ma i primi commenti avevano provocata una seconda edizione di tremila e prima che questa fosse esaurita venne preparata una terza ristampa di cinquemila. Dopo che un editore di Londra ebbe stipulato, per telegrafo, un accordo per l’edizione inglese, giunse notizia che erano in corso traduzioni dell’opera in francese, in tedesco e nelle lingue scandinave. L’attacco alla scuola di Maeterlinck, sferrato al momento opportuno, scatenò una polemica per la quale già esistevano le premesse. Saleeby e Haeckel appoggiarono e difesero La vergogna del sole, una volta tanto d’accordo nel sostenere la stessa tesi. Crookes e Wallace si schierarono invece dall’altra parte, mentre Sir Oliver Lodge tentò un compromesso che fosse compatibile con le sue particolari teorie cosmiche. I seguaci di Maeterlinck si raccolsero sotto la bandiera del misticismo. Chesterton fece ridere tutto il mondo con una serie di saggi sull’argomento a suo dire imparziali, e tutta la questione – l’oggetto della discussione e i protagonisti del dibattito – rischiarono di essere spazzati via come fuscelli sotto le tremende bordate indirizzate contro di loro da George Bernard Shaw. Inutile dire che nell’agone erano scesi, accanto a questi, molti altri personaggi minori e comprimari, e che la confusione e l’asprezza della lotta divennero tremende.
Martin ricevette una lettera dai suoi editori. «Stiamo assistendo all’evento straordinario», scrivevano, «di un saggio filosofico che si vende come un romanzo. A questo successo hanno contribuito la felice scelta dell’argomento e una serie di circostanze favorevoli. Naturalmente stiamo facendo di tutto per sfruttare il momento propizio. Più di quarantamila copie sono già state vendute negli Stati Uniti e nel Canada, ed è già prevista una nuova edizione di ventimila esemplari. Stiamo facendo gli straordinari per cercare di soddisfare la domanda, che per altro abbiamo contribuito a creare; la spesa pubblicitaria è già di cinquemila dollari. Ci stiamo avviando a vendite da primato.
«Ci siamo permessi di allegare alla presente un contratto in duplice copia relativo al Suo prossimo libro. Ci pregiamo di farLe notare che abbiamo aumentato la percentuale dei Suoi diritti al venti per cento, il massimo cui possa arrivare una casa editrice seria. La preghiamo, se l’offerta è di Suo gradimento, di scrivere il titolo del libro nello spazio rimasto in bianco. Siamo disposti a pubblicare opere di qualunque argomento. Ove Lei già avesse manoscritti pronti per la stampa ci faciliterebbe il compito, perché ci consentirebbe di battere il ferro finché è caldo.
«Al ricevimento del contratto firmato saremo lieti di inviarLe un anticipo di cinquemila dollari sulle Sue future spettanze. Avendo grande fiducia nei Suoi libri, abbiamo intenzione di impegnarci a fondo nel loro lancio. Vorremmo anche discutere con Lei i termini di un altro contratto in cui Ella ci conceda, per un certo numero di anni, l’esclusiva della pubblicazione delle Sue opere in volume. Le faremo presto pervenire le nostre proposte».
Dopo aver letto la lettera, Martin fece un rapido calcolo e scoprì che il prodotto di quindici centesimi per sessantamila dava novemila dollari. Firmò poi il nuovo contratto, che completò scrivendo nello spazio bianco il titolo Il fumo della gioia, e lo spedì agli editori insieme con le venti novelle che aveva scritto prima di scoprire la formula per comporle automaticamente. L’assegno di cinquemila dollari della Singletree, Darnley & Co. gli pervenne immediatamente, a stretto giro di posta.
«Voglio che questo pomeriggio, verso le due, tu venga in centro con me, Maria», disse Martin alla donna la mattina stessa in cui ricevette il denaro. «O meglio, trovati alle due all’angolo fra Broadway e la Quattordicesima. Passerò io a prenderti».
Maria arrivò puntuale nel luogo fissato, convinta che Martin volesse regalarle un paio di scarpe e fu delusa quando lo vide passare oltre la vetrina di un negozio di calzature e immergersi, insieme con lei, in un ufficio immobiliare. Ciò che accadde in quel luogo si impresse per sempre nella sua memoria come un sogno. Cortesi signori le sorrisero graziosamente mentre parlavano con Martin e fra di loro; si sentiva il ticchettio di una macchina per scrivere; si apposero firme a un documento scritto in termini molto solenni; fra quelli che firmarono c’era anche il suo padrone di casa; e quando tutto fu finito, e si ritrovarono sul marciapiede, il proprietario le si avvicinò e le disse: «Bene, Maria, questo mese non mi dovrai pagare i sette dollari e mezzo».
La donna rimase così stupefatta da non riuscire a parlare.
«E neanche il mese prossimo, e quello dopo e quello dopo ancora», aggiunse il padrone di casa.
Lei lo ringraziò confusa, come se l’altro le stesse facendo un favore. Solo al ritorno nella sua casa di North Oakland si rese conto, dalle conversazioni con i vicini e dopo un’indagine condotta dal droghiere portoghese, di essere diventata la proprietaria dell’alloggio in cui abitava e per il quale per tanto tempo aveva pagato l’affitto.
La stessa sera Martin, scendendo dal tram, vide il suo vecchio fornitore uscire sulla via a salutarlo e a chiedergli perché non si servisse più presso di lui; gli rispose che non si preparava più i pasti in casa, e, entrato in negozio, bevve un bicchiere di vino offerto dalla ditta. Notò che era il migliore fra quelli che il droghiere teneva sugli scaffali.
«Maria», annunciò Martin quella sera, «ho intenzione di lasciare questa casa. Ma presto te ne andrai anche tu. Allora potrai affittarla e incassare la pigione. So che a San Leandro, o a Haywards, hai un fratello che lavora nella produzione del latte. Voglio che domani tu rimandi ai clienti il bucato senza lavarlo – senza lavarlo, capito? – e che vada a trovarlo a San Leandro o a Haywards, o dove diavolo si trovi. Digli di venirmi a trovare. Per un po’ mi fermerò al Metropole di Oakland. Sono sicuro che è capace di riconoscere un buon allevamento di mucche da latte».
Fu così che Maria divenne proprietaria di immobili e unica padrona di un caseificio, con due salariati che facevano il lavoro per lei e un conto in banca che aumentava costantemente sebbene tutti i suoi figli avessero adesso scarpe ai piedi e andassero a scuola. Pochi hanno il privilegio di conoscere nella realtà le fate benefiche dei loro sogni; e Maria, che per tutta la vita aveva lavorato sodo e che non sognava mai di fate benefiche, ne incontrò una nei panni di un ex lavandaio.
Nel frattempo, tutti avevano cominciato a chiedersi chi mai fosse questo Martin Eden. Lui si era rifiutato di fornire agli editori i propri dati biografici, ma ciò non fu un ostacolo per i giornali. Oakland era la sua città e i cronisti scovarono decine di persone in grado di dare loro le informazioni richieste. Quello che egli era e non era, ogni cosa che aveva fatto e molte altre che non aveva fatto, tutto ciò fu rivelato dalla stampa per il diletto del pubblico, accompagnato da istantanee e foto – queste ultime distribuite dal fotografo locale che, avendo una volta fatto il ritratto a Martin, lo mise sul mercato affermando di averne i diritti esclusivi. Dapprima Martin, pieno di disgusto per le riviste illustrate come per ogni altra espressione della società borghese, si oppose a quella pubblicità, ma infine cedette, perché in tal modo avrebbe avuto minori fastidi. Rifletté che non poteva negarsi agli inviati speciali che avevano fatto tanti chilometri per vederlo. Le sue giornate divennero quindi piene di faticosi impegni, che accettò di buon grado, anche perché, non essendo più assorbito dalla lettura e dallo scrivere, doveva pur occupare in qualche modo quelle ore; si concesse quindi agli umori del pubblico, rilasciò interviste, espresse le sue opinioni in materia di letteratura e di filosofia e accettò persino inviti in case borghesi. Era caduto in uno stato mentale di strana tranquillità, che gli faceva sopportare qualunque cosa. Perdonava a tutti, persino al giovane cronista che lo aveva dipinto come un sovversivo, al quale concesse un servizio di un’intera pagina con fotografie scattate apposta per l’occasione.
Di tanto in tanto vedeva Lizzie. La ragazza era palesemente contrariata dalla fama che lo aveva raggiunto, perché questa accentuava il divario che li separava. Fu forse nella speranza di ridurlo che la ragazza cedette ai suoi inviti di iscriversi alla scuola serale e poi a un istituto commerciale e di farsi vestire da una sarta alla moda che chiedeva prezzi esorbitanti. Lizzie faceva enormi progressi da un giorno all’altro, fino a quando a Martin non venne il dubbio che forse stava sbagliando, perché capì che lo assecondava solo per amor suo. La ragazza stava infatti cercando di abbracciare quei valori che, ai suoi occhi, dovevano essere importanti per lui; e tutto ciò benché egli non le avesse lasciato speranze, trattandola come un fratello e andando raramente a trovarla.
Scaduto fu lanciato in tutta fretta sul mercato dalla Meredith-Lowell Company nel momento della sua massima popolarità, ed essendo un’opera di narrativa ebbe un successo di vendite ancora maggiore di quello registrato dalla Vergogna del sole. Per diverse settimane il suo nome fu legato all’impresa senza precedenti di avere due libri ai primi posti nella classifica dei best-sellers. Il racconto non si impose solo presso i lettori di romanzi, ma fu anche letto avidamente dagli estimatori del saggio, colpiti dall’afflato cosmico che vibrava in quella storia di mare. Dopo avere attaccato con straordinaria efficacia la letteratura del misticismo, aveva dato una dimostrazione pratica delle proprie posizioni teoriche, rivelandosi in tal modo come uno di quei rarissimi geni che riescono ad essere grandi sia come creatori sia come critici.
Il denaro a profusione, la fama crescente, il fatto di essere salito all’improvviso all’orizzonte letterario, in cui la sua stella balenò come la luce di una cometa, suscitarono in lui più un sorriso divertito che un vero interesse. Era rimasto colpito da un banale episodio, di cui nessuno venne mai a conoscenza. Ma se la gente lo avesse saputo sarebbe rimasta sbalordita che egli potesse essere sorpreso da un fatto così insignificante, eppure tanto importante per lui. La piccola cosa, che nella sua mente aveva assunto dimensioni gigantesche, era l’invito a cena da parte del giudice Blount. Quello stesso giudice Blount che lui aveva insultato e trattato in modo così abominevole lo aveva invitato a casa sua incontrandolo casualmente in strada. Martin pensò alle numerose volte in cui vedendolo dai Morse non lo aveva invitato. Perché non lo aveva fatto? si chiedeva. Nel frattempo non era cambiato, era lo stesso Martin Eden di allora. In che cosa era diverso? Solo perché la roba che aveva scritto era apparsa stampata nelle vetrine delle librerie? Ma a quel tempo aveva già fatto queste cose, non le aveva composte dopo quegli incontri. Erano opere già completate proprio nel momento in cui Blount, ripetendo un’opinione diffusa, si era fatto beffe di Spencer e del suo intelletto. Non era per se stesso dunque che il giudice lo invitava a cena, ma per un valore fittizio che gli era stato attribuito.
Martin accettò l’invito sogghignando, sorpreso di essere diventato tanto disponibile. E durante la serata, a cui parteciparono, insieme con le signore, cinque o sei personaggi altolocati, il giudice Blount, con il caldo appoggio del giudice Hanwell, sollecitò Martin, stella di quell’eletto consesso, a permettere che il suo nome fosse raccomandato per essere ammesso allo Styx, il circolo estremamente esclusivo a cui appartenevano uomini che non erano solo ricchi ma anche di successo. Martin, perplesso più che mai, rifiutò.
Fu molto impegnato nell’attività di collocamento dei manoscritti. Gli editori lo assediavano. Di lui si scrisse che era uno stilista, ma che sotto la forma c’era la sostanza. Dopo aver pubblicato La culla della bellezza, la «Northern Review» gli aveva scritto per commissionargli una mezza dozzina di saggi simili, che egli avrebbe loro inviato scegliendoli fra quelli del mucchio se nel frattempo la «Burton’s Magazine» non gli avesse offerto un compenso di cinquecento dollari ad articolo per una serie di cinque articoli. Rispose che accettava per la cifra di mille dollari per ciascuno dei saggi. Ricordava che tutti quei manoscritti erano stati respinti, con poche frasi fredde e stereotipate, dagli stessi periodici che ora facevano a gara per assicurarseli. Li avrebbe fatti soffrire come loro avevano fatto soffrire lui. La «Burton’s Magazine» pagò la somma che lui aveva indicato per cinque di quei saggi; i restanti quattro furono pubblicati, alle stesse condizioni, dal «Mackintosh’s Monthly» dal momento che la «Northern Review» non poteva permettersi di pagare cifre così elevate. Vennero così alla luce Gli alti sacerdoti del mistero, Gli adoratori dei sogni, La misura dell’io, La filosofia dell’illusione, Dio e la zolla, Arte e biologia, I critici e le provette, Polvere di stelle e La dignità dell’usura, suscitando dibattiti e polemiche destinati ad acquietarsi solo dopo parecchio tempo.
Dai direttori delle riviste ricevette diverse lettere in cui lo si invitava a indicare le condizioni della sua collaborazione. Lo fece, ma solo per opere che aveva già scritto, rifiutando risolutamente di impegnarsi in cose nuove. Il pensiero di riprendere in mano carta e penna lo faceva impazzire. Aveva visto Brissenden fatto a pezzi dalla plebe, e benché questa stessa folla ora lo acclamasse non era mai riuscito a superare il trauma di quell’esperienza e ad avere per la massa un minimo di rispetto. Considerava quella popolarità una disgrazia e un tradimento dell’amico, ma, pur provandone ribrezzo, decise di farsi forza per continuare a sfruttare la miniera d’oro.
I direttori editoriali gli scrivevano lettere di questo tenore: «Circa un anno fa fummo purtroppo costretti a respingere la sua raccolta di poesie d’amore, che pure ci avevano favorevolmente impressionato, a causa di impegni editoriali presi in precedenza. Se l’opera è ancora inedita, ed Ella ce la farà gentilmente pervenire, saremo lieti di pubblicarla integralmente alle condizioni che ci vorrà precisare. Siamo anche disposti ad offrirle un congruo compenso per la sua successiva pubblicazione in volume».
Ricordandosi di avere composto molto tempo prima una tragedia in versi sciolti, Martin decise di mandarla al posto della raccolta richiesta. Poco prima di spedirla a destinazione la rilesse, notandone la dilettantesca immaturità e concludendo che era, in ogni caso, uno scritto di scarso valore. L’inviò lo stesso e se lo vide pubblicare, a eterna infamia del direttore. I lettori rimasero increduli e indignati: troppa era la differenza fra la superiore qualità delle creazioni di Martin Eden e quell’ignobile pastrocchio. Si disse allora che non era opera sua e che era stata goffamente raffazzonata dalla redazione del periodico imitando lo stile dell’autore, oppure che Martin Eden, all’apice del successo, aveva deciso, imitando Dumas padre, di assumere alcuni «negri», cui affidava la redazione di opere che spacciava per sue. Tuttavia, dopo che egli ebbe chiarito come quella tragedia fosse un prodotto del suo apprendistato letterario e che l’aveva inviata solo cedendo a insistenti suppliche, ci fu una risata generale alle spalle della rivista, che si affrettò a sostituire il direttore. La tragedia non apparve mai in volume, anche se Martin intascò senza esitare l’anticipo sui diritti d’autore.
Il «Coleman’s Weekly» inviò a Martin un lunghissimo telegramma, del costo di quasi trecento dollari, con l’offerta di scrivere una serie di articoli a un compenso di mille dollari l’uno. Avrebbe dovuto compiere un viaggio negli Stati Uniti, completamente spesato dalla rivista, e parlare di tutto ciò che lo avesse interessato. Per dimostrargli la grande libertà di scelta di cui avrebbe goduto, la parte più cospicua del telegramma dava, a titolo puramente indicativo, un elenco di possibili soggetti da trattare, con l’unica condizione che doveva limitarsi a temi riguardanti gli Stati Uniti. Nel telegramma di risposta, che spedì a carico del destinatario, Martin dichiarò che, con grande rammarico, era nell’impossibilità di accettare la proposta.
Wiki-Wiki, pubblicato sul «Warren’s Monthly», si affermò rapidamente. Impaginato con ampi margini e un’elegante veste tipografica, si vendette molto, soprattutto fra i lettori che si trovavano nei luoghi di villeggiatura. Il successo commerciale fu notevole e la critica fu unanime nel sostenere che avrebbe trovato posto accanto ad altri due racconti classici di due grandi scrittori: Il diavolo nella bottiglia e Pelle di zigrino.
Tuttavia la raccolta Il fumo della gioia fu accolta dal pubblico con freddezza e perplessità. L’audacia e l’anticonformismo delle novelle furono un colpo per la morale e i pregiudizi borghesi. Ma quando Parigi impazzì per il libro, che era stato immediatamente tradotto in francese, anche i lettori inglesi e americani si entusiasmarono e comprarono un numero di copie così sbalorditivo che Martin riuscì a convincere una casa editrice tradizionalmente prudente come la Singletree, Darnley & Co. a concedergli una percentuale secca del venticinque per cento per il suo terzo libro e il trenta per cento per il quarto. Questi due volumi comprendevano tutti i racconti brevi già comparsi, o di prossima pubblicazione, sulla stampa periodica. Nel primo si trovavano Il suono delle campane e le novelle dell’orrore, nel secondo Avventura, Il vaso, Il vino della vita, Il gorgo, La strada della lotta e quattro altri. La Lowell-Meredith Company si assicurò la raccolta completa dei suoi saggi, mentre alla Maxmillian Company andarono le Liriche del mare e il Ciclo d’amore; quest’ultimo uscì anche a puntate sul «Ladies’ Home Companion», che, per averlo, aveva dovuto pagare una cifra da capogiro.
Martin tirò un sospiro di sollievo dopo avere collocato l’ultimo manoscritto, perché in tal modo si era avvicinato al castello di zolle d’erba e alla bianca goletta rivestita di rame. Aveva comunque smentito l’affermazione di Brissenden, secondo cui le opere valide non comparivano mai sulle riviste. Il suo successo dimostrava proprio il contrario. Nell’intimo, tuttavia, sentiva che l’amico aveva ragione. Più che da quei racconti, il grande clamore intorno al suo nome era stato provocato dalla Vergogna del sole. Le opere narrative erano cose senza importanza, che tutti i periodici avevano respinto, ma la pubblicazione del saggio aveva suscitato polemiche e aveva richiamato su di lui un grande interesse. Se non ci fosse stata La vergogna del sole non ci sarebbe stato questo grande interesse; se non ci fosse stato il miracolo del grande successo di quest’opera non ci sarebbe stata la straordinaria fortuna di tutto ciò che aveva scritto. Che si trattasse di un miracolo era provato dal comportamento della Singletree, Darnley & Co., che aveva fatto uscire una prima edizione di millecinquecento copie della Vergogna del sole senza sapere se sarebbe mai riuscita a venderle tutte. Erano editori di provata esperienza, e quello strepitoso successo aveva sorpreso loro prima di ogni altro. Per loro era un vero e proprio miracolo, un’esperienza che non furono mai in grado di superare, ed ogni lettera che scrivevano rifletteva il reverente rispetto che provavano di fronte a quel primo misterioso evento. Non cercarono mai di spiegarlo perché non poteva avere spiegazioni. Era avvenuto e basta. Si era verificato contraddicendo tutto ciò che l’esperienza suggeriva.
Riflettendo su questo, Martin cominciò a nutrire dubbi sul valore della popolarità di cui godeva. Era la borghesia che comprava i suoi libri e gli procurava denaro a palate, ma, da quel poco che sapeva di questa classe, si meravigliava che potesse capire ciò che aveva scritto e apprezzarlo. La sua bellezza interiore e la sua potenza espressiva non dicevano nulla alle centinaia di migliaia di persone che lo acclamavano e compravano i suoi libri. Era solo un personaggio di moda, un avventuriero che aveva preso d’assalto il Parnaso in un momento in cui gli dei erano distratti. Le folle lo leggevano e lo applaudivano con lo stesso fanatismo ottuso con cui si erano gettate su Effimera di Brissenden prima di farlo a pezzi – un branco di lupi che lo esaltava invece di sbranarlo. Finire nella polvere o sugli altari era solo una questione di fortuna. Di una sola cosa era assolutamente certo: Effimera era infinitamente superiore a ogni opera che egli avesse scritto o che sentiva dentro di sé. Era una poesia immortale. L’onore che la massa gli tributava era povera cosa, perché era la stessa massa che aveva gettato nel fango quel poema sublime. Emise un profondo sospiro di soddisfazione. Era contento di aver venduto l’ultimo manoscritto e di poter presto dichiarare chiusa tutta quella storia.
XLIV
Il signor Morse incontrò Martin nella hall dell’Hotel Metropole. Non era chiaro se si trovasse lì per caso, per sbrigare qualche altra faccenda, o se ci fosse andato con il fine esplicito di incontrarlo e di invitarlo a cena. Comunque stessero le cose, Martin ricevette un invito di questo tenore dal padre di Ruth, da colui che gli aveva proibito di frequentare la sua casa e che aveva indotto la figlia a rompere il fidanzamento.
Martin non si arrabbiò, e non assunse neppure un’aria sostenuta. Trattò invece l’altro con tolleranza, chiedendosi per tutta la durata del colloquio che effetto facesse dovere inghiottire quel rospo. Non declinò l’invito, che rinviò a una remota data da destinarsi, e chiese notizie della famiglia, particolarmente di Ruth e della signora Morse. Pronunciò il nome di lei senza esitare, con naturalezza, pur rimanendo sorpreso in cuor suo di non aver provato alcuna emozione, di non avere avvertito il vecchio, familiare tumulto del cuore e il caldo pulsare del sangue.
Ora riceveva molti inviti a cena, che a volte accettava. Alcuni si facevano presentare solo per questo scopo ed egli continuò a riflettere su quella piccola cosa che stava diventando enorme. Ad aumentare ancor più le sue perplessità, anche Bernard Higginbotham gli chiese di andare a cena a casa sua. Ricordò i giorni di fame disperata in cui nessuno si preoccupava di nutrirlo. Avrebbero dovuto farlo allora, quando a volte non riusciva a reggersi in piedi ed era diventato magro e smunto. Era un paradosso: quando aveva bisogno di mangiare nessuno si curava di lui, mentre adesso che poteva rimpinzarsi e stava perdendo l’appetito, gli inviti a pranzo gli arrivavano da tutte le parti. Perché? Non era giusto; ora lui non aveva alcun merito particolare che lo rendesse diverso da prima. Le opere che ora venivano pubblicate erano già state portate a termine allora. Il signore e la signora Morse, che lo consideravano un fannullone e uno scansafatiche, e tramite Ruth lo avevano sollecitato a trovarsi un impiego in un ufficio, erano al corrente delle cose che faceva perché Ruth passava loro i manoscritti. Ciò che leggevano allora era ciò che adesso gli procurava tanta popolarità su tutti i periodici, ed era proprio il fatto che il suo nome fosse così celebre che li aveva spinti ad invitarlo.
Una cosa era certa: i Morse non si erano mai preoccupati né della sua persona, né dei suoi scritti. Era dunque evidente che ora non lo volevano per se stesso o per ciò che aveva fatto, ma solo per la notorietà che gli era piombata addosso, per il prestigio che aveva acquisito e anche – perché no? – per il patrimonio di circa centomila dollari che possedeva. Era così che la società borghese valutava un uomo, e chi era mai lui per pretendere che fosse altrimenti? E tuttavia l’orgoglio lo portava a rifiutare la stima di persone che ragionavano in questo modo. Voleva essere apprezzato per se stesso, oppure per il suo lavoro, che era, dopo tutto, un’espressione della sua personalità. Era così che lo considerava Lizzie, per la quale neppure ciò che faceva aveva alcuna importanza. Lei apprezzava l’uomo, come l’idraulico Jimmy, come tutti quelli della vecchia banda. Ne aveva avuto spesso la prova al tempo in cui facevano tante scorribande insieme, e ne aveva ricevuto la conferma quella domenica allo Shell Mound Park. Al diavolo la sua opera! Quello che a loro piaceva, e per cui erano pronti a fare a botte, era proprio lui, Mart Eden, un buon compagno e un tipo davvero in gamba.
E poi c’era Ruth. Lei gli aveva voluto bene come uomo, su questo non c’erano dubbi, ma, per quanto forte, quel sentimento non era stato capace di vincere i pregiudizi borghesi. Si era opposta alla sua decisione di scrivere soprattutto perché, così gli era parso, non gli faceva guadagnare denaro. Era questa la critica che aveva rivolto al Ciclo d’amore. Anche lei lo aveva sollecitato a trovarsi un lavoro. A dire la verità aveva usato il termine più fine di «occupazione», ma era la stessa cosa, e comunque lui preferiva ricorrere alla nomenclatura che gli era più familiare. Le aveva letto tutto ciò che aveva scritto – poesie, racconti, saggi – Wiki-Wiki, La vergogna del sole, tutto. E ciò nonostante Ruth gli raccomandava sempre e insistentemente di trovarsi un posto, di andare a lavorare – santo cielo! come se non avesse faticato, non si fosse privato del sonno, non avesse sputato sangue, al fine di rendersi degno di lei.
E la piccola cosa diventava più grande. Era tranquillo e in buona salute, mangiava regolarmente, dormiva a lungo, ma quella piccola cosa che si ingrandiva stava diventando un’ossessione. Opera finita. Quella piccola frase gli rodeva il cervello. Seduto di fronte a Bernard Higginbotham, davanti a un sostanzioso pasto domenicale nella casa sopra ai Magazzini Higginbotham, faceva sforzi sovrumani per non urlargli:
«Era un’opera finita! Ora mi dai da mangiare, ma allora mi lasciavi morire di fame, mi proibivi di venire a casa tua e imprecavi perché non volevo cercarmi un posto. Era un lavoro già fatto, completamente finito. Adesso, quando parlo io, non dici più quello che pensi; pendi dalle mie labbra e ascolti le mie parole con rispettosa attenzione. Se accuso il tuo partito di essere marcio e pieno di ladri non reagisci più con rabbia come una volta, ma emetti grugniti imbarazzati e ammetti che non ho tutti i torti. E perché? Perché sono famoso e ho un sacco di soldi, e non perché sono Martin Eden, un tipo simpatico che di solito dice cose intelligenti. Se affermassi che la luna è una grossa palla di formaggio, giureresti che ho ragione, o almeno non ti scandalizzeresti, perché ho un mucchio di dollari, ho montagne di dollari. Era un’opera finita; ti ripeto che era un lavoro già fatto quando tu mi disprezzavi e calpestavi come un verme schifoso».
Tuttavia Martin taceva. Anche se quel pensiero gli rodeva il cervello ed era un incessante tormento, sorrideva e riusciva anche ad essere tollerante. E di fronte al silenzio del grand’uomo, Bernard Higginbotham si sentiva ringalluzzito e riprendeva a parlare. Aveva avuto anche lui un successo di cui essere orgoglioso. Si era fatto da sé. Nessuno lo aveva aiutato. Non doveva nulla ad alcuno. Come cittadino faceva il suo dovere e come padre tirava su in modo esemplare la numerosa prole. E poi c’erano i Magazzini Higginbotham, monumento di laboriosità e intelligenza, per i quali aveva un affetto che altri provano solo per la moglie. Aprendo a Martin tutto il suo cuore, gli rivelò quanta abilità e lungimiranza fossero state profuse per metterli in piedi. E per loro aveva altri progetti, piani ambiziosi. Il quartiere si stava sviluppando con rapidità e il negozio era troppo piccolo. Se avesse avuto più spazio sarebbe riuscito a introdurre miglioramenti che gli avrebbero consentito di realizzare dei risparmi di denaro e personale. Ma ci sarebbe riuscito, prima o poi. Stava facendo grossi sacrifici per comprare l’area adiacente su cui costruire un altro fabbricato a due piani. Avrebbe affittato quello superiore, mentre il pianterreno sarebbe stato unito al negozio attuale per la nuova sede, ampliata, dei Magazzini Higginbotham. Parlando della nuova insegna che avrebbe occupato la lunghezza di entrambi gli edifici gli brillavano gli occhi.
Martin si distrasse: il ritornello di «opera finita» che continuava a tornargli nel cervello gli impediva di seguire il cicaleccio dell’altro. Cercò allora di sfuggire a quell’ossessione tornando alla realtà.
«Quanto hai detto che costerebbe?», chiese all’improvviso.
Il cognato si arrestò nel mezzo di uno sproloquio sulle possibilità commerciali del quartiere. Non aveva parlato di cifre, ma le aveva in mente perché aveva fatto più volte il calcolo.
«All’attuale prezzo del legname», disse, «quattromila possono bastare».
«Compresa l’insegna?».
«Quella non l’ho contata. Verrà quando c’è il fabbricato».
«E il terreno?».
«Altri tremila».
Vedendo che Martin stava scrivendo un assegno si chinò in avanti passandosi la lingua sulle labbra, mentre le mani si aprivano e si chiudevano nervosamente, fino a quando diede un’occhiata alla cifra: settemila dollari.
«Non… non posso permettermi di pagare più del sei per cento», disse rauco.
A Martin era venuto da ridere, ma riuscì a trattenersi e a chiedere:
«E quanto sarebbe?».
«Vediamo un po’. Al sei per cento… sei per sette… quattrocentoventi».
«Cioè trentacinque dollari al mese, vero?».
Higginbotham annuì.
«Allora, se non hai obiezioni facciamo così».
Martin guardò Gertrude. «Non dovrai restituirmi questa somma se ti impegnerai a spendere trentacinque dollari ogni mese per pagare qualcuno che cucini, faccia il bucato e pulisca la casa. I settemila saranno tuoi se garantirai che Gertrude non dovrà più farti da sguattera. Accetti?».
Higginbotham inghiottì a fatica. Che sua moglie non dovesse più occuparsi delle faccende domestiche era un affronto per la sua anima parsimoniosa. Quel magnifico regalo gli era stato fatto per indorare una pillola amarissima. Avere una moglie che non era più costretta a lavorare gli bruciava.
«Se non ci stai», incalzò Martin, «pago io i trentacinque al mese per…». E allungò la mano per riprendersi l’assegno. Ma Bernard Higginbotham lo precedette fulmineo ed esclamò tenendoselo stretto:
«Accetto! Accetto!».
Salendo sul tram, Martin era stanco e nauseato. Alzò gli occhi all’orgogliosa insegna del negozio.
«Porco», ringhiò. «Porco, porco».
Quando la «Mackintosh’s Magazine» pubblicò La chiromante, accompagnandola con decorazioni di Berthier e due disegni di Wenn, Hermann von Schmidt, dimenticandosi di aver definito «osceni» quei versi, dichiarò che la poesia era stata ispirata da sua moglie e, avendo fatto in modo che l’informazione arrivasse alla stampa, si sottopose volentieri alle domande di un cronista, che in quell’occasione fu accompagnato da un fotografo e da un illustratore della redazione. Il risultato fu un’intera pagina del supplemento domenicale di un quotidiano riempita da fotografie e disegni idealizzati di Marian, dal racconto di molti particolari intimi di Martin Eden e della sua famiglia e dal testo integrale, a grandi caratteri, della Chiromante, stampato su licenza della «Mackintosh’s Magazine». La cosa fece scalpore nel rione; le buone comari furono orgogliose di aver conosciuto la sorella di un grande scrittore, mentre quelle che non avevano rapporti con lei si affrettarono a ronzarle intorno. Nella piccola officina per biciclette Hermann von Schmidt, gongolante, decise di ordinare un nuovo tornio. «È meglio della pubblicità», disse a Marian, «e non costa nulla».
«Dovremmo farlo venire a cena», suggerì la moglie.
E Martin andò a cena e si comportò in modo simpatico con il pingue grossista di carni e l’ancor più grossa moglie di lui – persone importanti, che potevano essere utili a un giovane ambizioso come Hermann von Schmidt. Ma c’era voluto il richiamo del cognato famoso per farle venire in quella casa. Un altro ospite attirato lì dalla stessa prospettiva era l’ispettore delle agenzie per la Costa del Pacifico della società produttrice di biciclette Asa, che von Schmidt voleva ingraziarsi perché da lui avrebbe potuto ottenere la rappresentanza di quella marca per la zona di Oakland. Per queste ragioni il meccanico fu lieto di avere un tale cognato, ma in cuor suo non riusciva a capire perché suscitasse tanto interesse: nel silenzio della notte infatti, mentre la moglie dormiva, si era immerso nella lettura dei libri e delle poesie di Martin, e aveva deciso che la gente era proprio stupida a comprarli.
Da parte sua, Martin aveva compreso fin troppo bene la situazione e, comodamente appoggiato allo schienale della sedia, con gli occhi fissi alla faccia del cognato, sognava di spaccargliela a forza di pugni – testone di un tedesco! E tuttavia in lui c’era una cosa che gli piaceva. Per quanto povero e deciso a farsi strada, aveva assunto una domestica che aiutasse Marian nei lavori più pesanti. Dopo cena Martin parlò con l’ispettore dell’Asa e lo convinse a soddisfare le attese di Hermann, dando anche al cognato un sostegno finanziario perché potesse allestire il miglior negozio di biciclette di Oakland. Oltre a ciò, in un colloquio a quattr’occhi che ebbe in seguito con von Schmidt, gli disse di guardarsi in giro per vedere se poteva trovare qualche concessionaria d’auto con annessa officina, perché poteva benissimo gestire con successo entrambe le attività.
Al momento dell’addio, Marian, con gli occhi pieni di pianto, buttò le braccia al collo del fratello dicendogli di volergli bene e di avergliene sempre voluto. Martin intuì che era vero, ed interpretò l’evidente esitazione nel mezzo di quella dichiarazione, durante la quale la sorella si profuse in altre lacrime, in baci e in incoerenti balbettii, come una richiesta di perdono per non avere avuto fede in lui e per avere insistito che si cercasse un lavoro.
«Proprio non è capace di pensare ai soldi, questo è sicuro», confidò più tardi Hermann von Schmidt alla moglie. «Si è infuriato quando gli ho accennato agli interessi e ha detto che se ne sbatteva della restituzione e che se tiravo ancora fuori quel discorso mi staccava questo mio testone tedesco. Proprio così mi ha chiamato – testone tedesco. Ma è un bravo tipo, anche se di affari non capisce niente. Mi ha fatto un grosso piacere, è proprio bravo».
A Martin arrivavano inviti a valanghe, e più ne venivano più lui si sentiva perplesso. Partecipò come ospite d’onore a un banchetto dell’Arden Club in compagnia di uomini illustri, dei quali per tutta la vita aveva sentito parlare e letto sui giornali; e costoro gli dissero che leggendo Il suono delle campane sul «Transcontinental» e La peri e la perla su «The Hornet» avevano immediatamente intuito che lui era un personaggio vincente. Mio Dio! rifletté Martin, e pensare che ero misero e affamato! Perché non mi avete invitato a un pranzo allora? Quello era il momento giusto. Se mi offrite la cena ora per un’opera finita, perché non lo avete fatto quando ne avevo bisogno? Ai due racconti non ho cambiato una sola parola. No; adesso non mi nutrite per qualcosa che ho finito nel frattempo, ma solo perché lo fanno tutti e perché farlo è un onore. Mi date da mangiare perché vi comportate come gli animali che vivono in un gregge, perché appartenete alla plebaglia, perché in questo momento l’unica preoccupazione della massa vile e ottusa è quella di nutrirmi. Come si collega tutto questo con Martin Eden e l’opera da lui finita? si chiese amaramente, prima di alzarsi per rispondere con parole argute e intelligenti a un brindisi arguto e intelligente.
Era sempre la stessa cosa. Dovunque si trovasse – al Circolo della Stampa, al Redwood Club, ai tè delle signore, alle riunioni letterarie – veniva ricordato sempre il momento in cui erano stati pubblicati per la prima volta Il suono delle campane e La peri e la perla. E inevitabilmente, ossessivamente, Martin rimuginava la stessa domanda: Perché non mi avete invitato allora? Erano opere finite, a cui non ho tolto una virgola. Allora erano grandi e e sublimi come adesso. Ma voi non mi nutrite per le qualità che questi racconti hanno, né per qualunque altra cosa che io abbia scritto. Mi date da mangiare perché ora è di moda farlo, perché tutta la plebaglia impazzisce a questa idea.
Spesso, durante le riunioni mondane, gli avveniva di scorgere all’improvviso in mezzo alla compagnia un giovane bullo con la giacca squadrata e il cappello con la tesa rigida. Gli capitò un pomeriggio al Gallina Club di Oakland. Alzatosi dalla sedia per attraversare il palco, lo vide entrare con passo spavaldo dal grande ingresso in fondo al salone. Cinquecento donne vestite all’ultima moda volsero la testa per scoprire a cosa fosse diretto lo sguardo intento e fisso di Martin, ma videro solo il passaggio vuoto in mezzo alla sala. Lui invece osservò il giovinastro avanzare ondeggiando e si chiese se si sarebbe tolto il cappello, che teneva sempre sulla testa. Percorso il passaggio centrale salì fino alla pedana. Martin si sarebbe messo a piangere davanti a quel simulacro giovanile di se stesso al pensiero di che cosa lo aspettava. Arrivò sulla pedana, si diresse verso Martin e quando gli fu vicinissimo si dissolse nel nulla. Le cinquecento signore batterono con discrezione le mani inguantate per aiutare quel grand’uomo che era loro ospite a vincere la timidezza. Martin si riscosse, sorrise e cominciò a parlare.
Il preside della scuola, un simpatico vecchietto, fermò Martin in strada per dirgli che si ricordava di lui e di quando era venuto nel suo ufficio in occasione della sua espulsione dall’istituto a causa di una rissa.
«Ho letto in una rivista il tuo Il suono delle campane un po’ di tempo fa», disse. «Un racconto degno di Poe. Splendido, l’ho trovato splendido!».
Sì, e per due volte, nei mesi seguenti, ci eravamo visti in strada senza che tu mi riconoscessi, stava per rispondergli Martin. In entrambi i casi stavo andando al banco dei pegni perché avevo lo stomaco vuoto. Era un’opera già finita, ma tu non mi hai neanche guardato in faccia. Perché lo fai adesso?
«Proprio l’altro giorno suggerivo a mia moglie», stava dicendo l’altro, «che sarebbe stato bello averti a cena una sera. E lei si è dichiarata d’accordo con me. Sì, proprio d’accordo».
«A cena?», chiese Martin con un tono così brusco che parve il ringhio di un cane.
«Beh, sì… a cena… una cosa alla buona con noi, con il tuo vecchio preside, briccone che non sei altro», disse l’altro cercando di dargli una pacca affettuosa.
Martin proseguì per la strada sbalordito. All’angolo si fermò e si guardò attorno perplesso.
«Accidenti!», disse alla fine. «Il vecchio aveva paura di me».
XLV
Un giorno venne a trovarlo Kreis – uno di quelli della «vera feccia»; Martin lo accolse con sollievo e ascoltò gli straordinari particolari di un progetto così fantastico da interessarlo più come narratore che come finanziatore. Durante l’esposizione Kreis si interruppe solo per il tempo sufficiente a dirgli che gran parte della Vergogna del sole era un cumulo di scemenze.
«Ma non sono venuto qui a blaterare di filosofia», continuò. «Quello che voglio sapere è se sei o non sei disposto a mettere un migliaio di dollari in questa operazione».
«No, la mia scemenza non arriva fino a questo punto», rispose Martin. «Ma farò un’altra cosa. Tu mi hai regalato la serata più bella della mia vita. Mi hai dato quello che non si può comprare con i soldi. Ora io ho una ricchezza che mi lascia indifferente. Sono disposto a regalarti mille dollari di un patrimonio che per me non ha nessun valore per ricompensarti del dono di una serata senza prezzo. Tu hai bisogno di questo denaro e io ne ho più del necessario. Tu lo vuoi. È per questo che sei venuto. Non occorre dunque che tu la faccia tanto lunga. Te lo do; è tuo».
Kreis ripiegò l’assegno e se lo mise in tasca senza palesare alcuna sorpresa.
«A queste condizioni mi impegno a fornirti molte altre serate come quella», disse.
«Troppo tardi», rispose Martin scuotendo il capo. «Per me è stata un’esperienza unica. Ero al settimo cielo. So che per te è una cosa normale, ma per me non lo è stata. Non proverò mai più emozioni così intense. Ho chiuso con la filosofia. Non voglio più sentirne parlare».
«Sono i primi dollari che abbia mai ricavato dalla filosofia», osservò Kreis soffermandosi sulla porta. «Peccato che saranno anche gli ultimi».
Un giorno Martin incrociò in strada la signora Morse, che lo salutò con un sorriso e un cenno del capo. Egli le sorrise a sua volta togliendosi il cappello. Questo episodio, che un mese prima lo avrebbe disgustato o incuriosito, inducendolo a mille congetture sui pensieri della signora in quel momento, non gli provocò alcuna emozione. Né su di esso tornò successivamente. Lo dimenticò quasi subito, come avrebbe dimenticato il palazzo della Banca Centrale o il Municipio dopo esservi passato davanti. Tuttavia la sua mente lavorava con un fervore straordinario, occupata da un incessante roteare di pensieri intorno a un nucleo tormentoso, che gli divorava il cervello come un morbo implacabile. Al centro di quel vortice era il concetto di «opera finita», un’ossessione che cominciava la mattina e gli tornava nei sogni della notte. Ogni vicenda della vita circostante che gli penetrava attraverso i sensi si riduceva subito all’idea di «opera finita». Una logica spietata lo portava alla conclusione di avere perso ogni identità, di non esistere più. Mart Eden il teppista, il marinaio Mart Eden erano stati reali, erano stati lui; ma Martin Eden! il famoso scrittore non esisteva. Martin Eden il famoso scrittore era un vapore uscito dalla mente della gentaglia e, dalla mente della gentaglia, cacciato a forza nell’essere corporeo di Mart Eden, teppista e marinaio. Ma a lui non la davano a bere. Lui non era quel mito solare che la gentaglia adorava e a cui offrire pranzi sacrificali. Lui sapeva come stavano veramente le cose.
Sulle riviste leggeva articoli che lo riguardavano e, fissando le fotografie che accompagnavano i diversi servizi, non riusciva più ad associare la propria persona con la figura del ritratto. Era un uomo che nella vita aveva provato gioia e amore; che aveva osservato con indulgenza e comprensione le debolezze dell’esistenza; che aveva prestato servizio nel castello di prua, vagato in terre remote e capeggiato una banda al tempo delle risse. Era un uomo che era rimasto sconcertato dalle migliaia di libri della biblioteca pubblica, fra le cui file aveva imparato a muoversi e che adesso era in grado di dominare; era un uomo che aveva vegliato la notte consumando l’olio del lume, che era andato a letto con l’ansia, che aveva scritto libri. E poi forse il suo appetito era così colossale da dover essere saziato da tutta quella gentaglia?
Gli capitava anche di leggere cose divertenti. Tutte le riviste si disputavano il merito di averlo lanciato. Il «Warren’s Monthly» invitava i lettori a sottoscrivere l’abbonamento ricordando che la sua politica di ricerca di nuovi scrittori gli aveva consentito di presentare per la prima volta al pubblico, fra gli altri, Martin Eden. La stessa pretesa, avanzata da «The White Mouse», «The Northern Review» e «Mackintosh’s Magazine», fu seccamente smentita da «The Globe», forte del fatto che nei propri archivi era depositato il testo, manipolato, delle sventurate Liriche del mare. «Youth and Age», tornato in vita dopo essere riuscito a non pagare i debiti, pubblicò a beneficio dei suoi scarsi lettori di qualche sperduto distretto agricolo una comunicazione in cui rivendicava su di lui un diritto di priorità. La «Transcontinental» raccontò in modo discreto ma convincente come fosse arrivata alla scoperta di Martin Eden, ma la sua dichiarazione fu contestata da «The Hornet», proprietaria del manoscritto di La peri e la perla. In questo frastuono si perse la debole voce della Singletree, Darnley & Co., una casa editrice priva di una rivista che le consentisse di farsi valere.
I giornali fecero il calcolo di quanto guadagnava. Dopo alcune indiscrezioni sulle principesche offerte che gli erano state fatte da qualche rivista, ricevette visite da parte di preti di Oakland e cominciò ad essere sommerso da lettere con richieste di denaro. Ma fu soprattutto assediato dalle donne. Si pubblicarono sue fotografie in grande formato, e gli articoli dei giornali, affidati ad esperti del ramo, si dilungarono sulla sua faccia forte e abbronzata, sulle spalle robuste, sullo sguardo limpido e tranquillo e sulle guance leggermente incavate come quelle di un asceta. Questi ritratti lo fecero sorridere perché gli rammentavano gli anni scapestrati della gioventù. Spesso, fra le donne che conosceva, ne scorgeva qualcuna intenta a soppesarlo, a concupirlo. Queste cose lo facevano ridere, come il ricordo degli ammonimenti di Brissenden. Le donne non lo avrebbero mai mandato in rovina, di questo era certo. Da loro non gli sarebbe più venuto alcun pericolo.
Una volta, mentre accompagnava Lizzie alla scuola serale, notò che la ragazza si era accorta di una bella ed elegante signora che non gli toglieva gli occhi di dosso. Lizzie, che aveva capito il perché di tanta insistenza, ebbe un moto di contrarietà. Martin lo vide, ne comprese il motivo e le disse che una cosa di quel genere gli capitava spesso ma lo lasciava del tutto indifferente.
«E invece dovresti preoccupartene», rispose lei con occhi fiammeggianti. «Sei malato. Ecco quello che sei».
«Mai stato meglio in vita mia. Sono ingrassato più di due chili».
«Non è il corpo che sta male. È la testa. C’è qualcosa che non ti funziona nel cervello. Lo vedo anch’io, che sono una povera ignorante».
Martin continuò a camminarle accanto pensieroso, senza parlare.
«Non so cosa darei perché tu ne venissi fuori», esclamò Lizzie con trasporto. «Dovresti preoccuparti se le donne ti guardano in un certo modo… proprio uno come te. Va bene per degli smidollati, ma tu non sei il tipo. Accidenti, come vorrei che saltasse fuori una donna come si deve, e che ti piacesse!».
Dopo aver accompagnato Lizzie alla scuola tornò al Metropole. Quando fu nelle sue stanze si lasciò cadere su una poltrona, rimanendo seduto a lungo con lo sguardo fisso davanti a sé. Non aveva sonno, ma non riusciva a pensare a nulla. Aveva la mente vuota, tranne in alcuni momenti in cui spontaneamente visioni della memoria prendevano forma, luce e colore sotto le palpebre. Egli vedeva questi quadri ma li notava appena, quasi fossero sogni. E tuttavia non dormiva. Una volta si riscosse e guardò l’orologio. Erano appena le otto. Non aveva nulla da fare ed era troppo presto per andare a letto. Di nuovo gli si annebbiò il cervello e di nuovo le immagini presero a fluttuare. Non avevano nulla di particolare. Erano grovigli di foglie e di rami attraversati da una calda luce solare.
Sobbalzò al rumore di qualcuno che picchiava alla porta. Non essendo addormentato collegò subito quel suono con un telegramma, una lettera, o un domestico che forse gli riportava i vestiti dalla lavanderia. Mentre diceva «Avanti», pensò a Joe e si chiese dove fosse finito.
Assorto in quel ricordo non si voltò verso la porta che sentì chiudere piano piano. Poi ci fu un lungo silenzio durante il quale, dimenticandosi che qualcuno aveva bussato, rimase con lo sguardo fisso davanti a sé fino a che non udì un pianto di donna, un singhiozzare involontario, spasmodico, trattenuto e soffocato. Si girò e balzò immediatamente in piedi.
«Ruth!», esclamò confuso e sbigottito.
Il viso di lei era pallido e tirato. La ragazza era in piedi appena dentro la porta a cui si reggeva con una mano, mentre con l’altra si premeva il fianco. Le portò quindi entrambe in direzione di lui con gesto patetico e avanzò per andargli incontro. Nell’afferrarle le mani per tirarla fino alla poltrona Martin notò che erano gelide. Avvicinò un’altra poltrona e si sedette sull’ampio bracciolo. Era troppo turbato per parlare. In cuor suo la storia con Ruth era morta e sepolta. Provava le stesse sensazioni che avrebbe avuto se la lavanderia di Shelly Hot Springs avesse improvvisamente occupato l’albergo Metropole con il bucato di una settimana, che ora lo aspettava minaccioso. Parecchie volte fu sul punto di parlare, ma ogni volta esitò.
«Nessuno sa che sono qui», disse Ruth con un bel sorriso e un filo di voce.
«Che cosa hai detto?», chiese lui.
Fu sorpreso dal suono della propria voce.
Lei ripeté la frase.
«Oh», si limitò ad esclamare Martin, chiedendosi che cos’altro avrebbe potuto aggiungere.
«Ti ho visto entrare e ho aspettato per qualche minuto».
«Oh», fece lui nuovamente.
In vita sua non si era mai sentito così impacciato e incapace di formulare una sola idea. Aveva l’impressione di apparire stupido e goffo, ma non gli veniva in mente proprio nulla. Se la sarebbe cavata meglio con il bucato di Shelly Hot Springs.
«E allora sei entrata», disse infine.
Lei annuì con una punta di malizia e si allentò la sciarpa dal collo.
«Ti ho visto prima dall’altra parte della strada, mentre eri con quella ragazza».
«Oh, sì», rispose lui con semplicità. «L’ho accompagnata alla scuola serale».
«Allora, non sei contento di vedermi?», chiese lei al termine di un altro silenzio.
«Sì, sì». Lui parlava in fretta. «Ma non è stata un’imprudenza venire qui?».
«Mi sono infilata dentro. Nessuno sa che sono qui. Volevo vederti. Sono venuta a dirti che sono stata molto sciocca. Sono venuta perché non potevo più sopportare questa lontananza, perché il cuore mi ha costretta a venire, perché… perché volevo venire».
Si alzò dalla poltrona e andò verso di lui. Si fermò un istante tenendogli la mano sulla spalla e respirando affannosamente; quindi gli si rannicchiò fra le braccia. E Martin, sempre generoso, non volendola offendere con una ripulsa che sapeva le avrebbe inferto la peggiore ferita che una donna potesse ricevere, la trasse a sé e la tenne stretta.
Fu un abbraccio senza calore, un contatto privo di dolcezza. La teneva avvinta solo perché gli era venuta fra le braccia. Lei si appoggiò a lui e quindi, cambiando posizione, sollevò le mani fino a posargliele sul collo. Ma il fuoco che un tempo divampava a quel tocco era scomparso, e Martin provava ora solo un grande disagio.
«Perché tremi così?», le chiese. «Hai freddo? Vuoi che accenda la stufa?».
Egli cercò di sottrarsi a quella stretta, ma la ragazza lo serrò con più forza, scossa da violenti brividi.
«Sono solo nervosa», disse battendo i denti. «Fra un istante saprò controllarmi. Ecco, adesso va già meglio».
A poco a poco il tremito venne meno fino a cessare. Egli continuava a tenerla abbracciata ma non era più perplesso, perché aveva capito il motivo di quella visita.
«La mamma voleva che sposassi Charley Hapgood», disse.
«Charley Hapgood, quel tipo che è capace di dire solo banalità?», gemette Martin. E aggiunse: «E ora suppongo che tua madre voglia che tu sposi me».
Non diede a quella frase alcuna intonazione interrogativa, ma la pronunciò come un fatto incontrovertibile; davanti agli occhi gli ballavano colonne di cifre per diritti d’autore.
«Ora non si oppone; so soltanto questo», rispose Ruth.
«Mi considera un buon partito?».
Ruth annuì.
«Eppure non sono diverso rispetto a quando ruppe il fidanzamento», osservò lui. «Non sono cambiato affatto. Sono lo stesso Martin Eden di allora, anzi sono forse peggiorato… adesso fumo. Non lo senti dall’alito?».
Per tutta risposta lei gli premette le dita aperte sulle labbra con gesto aggraziato e giocoso, pronta al bacio che in passato si era sempre posato sulla mano aperta di lei. Ma questa volta le labbra di Martin rimasero immobili. Egli attese che Ruth allontanasse le dita consentendogli di parlare e proseguì.
«Non sono cambiato. Non ho un lavoro, non lo sto cercando e non ho intenzione di farlo in seguito. Inoltre credo sempre che Herbert Spencer sia un uomo grande e nobile e che il giudice Blount sia un perfetto imbecille. Ora lo so con certezza: l’altra sera sono stato a cena da lui».
«Però non hai accettato l’invito di papà», disse lei con aria di rimprovero.
«Allora lo sai! Chi lo ha mandato? Tua madre?».
Lei rimase in silenzio.
«Allora è stata proprio lei a dirgli di venire. L’avevo immaginato. E ora suppongo che abbia spedito anche te».
«Nessuno sa che sono qui», protestò lei. «Pensi che la mamma lo permetterebbe?».
«Ti permetterebbe di sposarmi, questo è sicuro».
Lei lanciò un grido acuto. «Oh, Martin, non essere crudele. Non mi hai baciata neanche una volta. Sei freddo come il marmo. Pensa a che cosa ho osato fare per te». Si guardò intorno con un brivido, sebbene nei suoi occhi ci fosse una buona dose di curiosità. «Pensa solo a dove mi trovo».
«Potrei morire per te! Potrei morire per te!». Alle orecchie gli risuonavano le parole di Lizzie Connolly.
«Perché prima non osavi farlo?», le chiese con voce aspra. «Quando non avevo un lavoro? Quando morivo di fame? Quando come uomo, come artista, ero esattamente ciò che sono adesso, lo stesso Martin Eden? Questa è la domanda che mi sono posto tante volte – e non riguarda solo te, ma tutti. Come vedi, non sono cambiato anche se questo improvviso aumento di valore che ho avuto mi fa venire continui dubbi. Ho la stessa carne e le stesse ossa, le stesse mani e gli stessi piedi. Sono lo stesso. Non ho alcuna forza o qualità nuova, il cervello è il medesimo di prima. Non ho neppure elaborato qualche nuova teoria letteraria o filosofica. Personalmente valgo né più né meno di quando nessuno mi voleva. Quello che mi tormenta è il perché ora invece mi vogliano tutti. Certamente non mi vogliono per me stesso, perché la mia personalità è esattamente uguale a quella che un tempo rifiutavano. Se mi vogliono dev’essere per qualche altra cosa, per qualcosa che è fuori di me, per qualcosa che non è parte di me! Vuoi che ti dica che cos’è? È il riconoscimento che ho avuto. Quel riconoscimento non sono io. È nella mente degli altri. Ed è anche per i soldi che ho fatto e che sto facendo. Ma quei soldi non sono io. Sono nelle banche e nelle tasche di questo e di quello… Ed è per questo, per il riconoscimento e per il denaro, che ora mi vuoi?».
«Mi spezzi il cuore», rispose lei singhiozzando. «Sai che ti amo e che sono qui perché ti amo».
«Temo che tu non abbia capito», disse lui con dolcezza. «Voglio dir questo: se tu mi ami, come mai il tuo sentimento adesso è molto più forte di quando hai avuto il cuore di rifiutarmi?».
«Dimentica il passato e perdonami», esclamò Ruth con passione. «Ti ho sempre amato, ricordalo, e ora sono qui, fra le tue braccia».
«Purtroppo sono un mercante sospettoso, che controlla sulla bilancia il peso di questo amore per cercare di scoprire di che cosa sia fatto».
Scioltasi dall’abbraccio, Ruth rimase seduta con il busto eretto fissandolo per parecchio tempo con uno sguardo penetrante. Era sul punto di rispondere, ma esitò e rinunciò.
«Ti dirò come la vedo io», proseguì Martin. «Quando in passato ero esattamente quello che sono adesso, nessuno della mia classe sociale pareva preoccuparsi di me. Quando in passato avevo già scritto tutti i miei libri, nessuno di quelli che avevano letto i manoscritti sembrava interessarsi a me. Anzi, erano ancor più indifferenti verso di me proprio perché avevo scritto quella roba, un’azione che era, come minimo, spregevole. «Trovati un lavoro», dicevano tutti».
Ruth espresse con un gesto il proprio dissenso.
«Sì, sì», insistette lui. «Anche se tu usavi il termine «occupazione». L’umile parola «lavoro» ti suona male, come gran parte di ciò che ho scritto. La trovi brutale. Ti assicuro che anch’io la giudicavo così quando tutti quelli che conoscevo me lo raccomandavano come si esorta una persona immorale a comportarsi bene. Ma torniamo a noi. La pubblicazione di ciò che avevo scritto e la fama che ne è derivata hanno cambiato la sostanza del tuo amore. L’opera di Martin Eden era già completata, ma tu non volevi sposarlo. L’amore che gli portavi non era forte abbastanza da permetterti di sposarlo. Ora invece lo è, e io non posso fare a meno di arrivare a concludere che questo nuovo vigore sia venuto come conseguenza della comparsa dei libri e della celebrità. Nel tuo caso non voglio parlare dei diritti d’autore, benché sia sicuro che essi abbiano avuto un certo peso nel mutamento che si è verificato in mamma e papà. Naturalmente tutto ciò non mi lusinga affatto, e soprattutto mi spinge a nutrire dubbi sull’amore, sulla sacralità dell’amore. È un sentimento così labile che per sopravvivere ha bisogno di pagine stampate e di notorietà? Si direbbe di sì. Ci ho riflettuto così intensamente da farmi venire il mal di testa».
«Povera, cara testa». Ruth sollevò la mano e gli passò le dita fra i capelli con un movimento carezzevole. «Non facciamole più male e ricominciamo daccapo. Ti ho sempre amato. Riconosco di essere stata debole nel cedere alla volontà della mamma. Non avrei dovuto. Ma ti ho sentito parlare tante volte della debolezza e della fragilità dell’uomo che spero tu voglia essere tollerante anche con me. Ho sbagliato. Perdonami».
«Ti perdono, certamente», disse lui con impazienza. «È facile farlo quando non c’è niente di cui io possa accusarti. Non devi chiedere scusa di nulla, perché ognuno agisce secondo le proprie convinzioni e più di tanto non si può pretendere da nessuno. A questa stregua potrei anch’io domandarti di perdonarmi per non avere cercato un lavoro».
«Volevo il tuo bene», obiettò lei, «e lo sai. Come avrei potuto amarti altrimenti?».
«Sì, saresti persino arrivata a distruggermi per il mio bene.
«Proprio così», proseguì, prevenendo i cenni di protesta di lei. «Sarebbe stata la mia fine di scrittore. Il realismo, che è una mia esigenza personale, è odiato dalla borghesia, una classe pusillanime piena di paura della vita, e tutti i tuoi sforzi erano tesi a istillarmi questo orrore della realtà. Avresti voluto rinchiudermi in cattività, isolarmi in una gabbia angusta e dorata dove tutti i valori dell’esistenza sono illusori, falsi e volgari». La vide agitarsi inquieta. «La volgarità – una sana volgarità, devo ammetterlo – è il fondamento dell’eleganza e della cultura borghesi. Come ho detto, tu volevi rinchiudermi in cattività, trasformarmi in un esemplare del tuo ceto, indurmi a condividere modelli ideali e pregiudizi classisti». Scosse il capo con aria triste. «Neppure adesso hai capito quello che dico. Tutti i miei sforzi per farti comprendere le cose in cui credo fermamente sono parole vuote, suoni privi di senso. Nel migliore dei casi sei sorpresa e un po’ divertita che questo rozzo giovane, uscito a fatica dai bassifondi, osi esprimere giudizi sulla tua classe chiamandola volgare».
La ragazza gli appoggiò stancamente la testa sulla spalla tremando di tanto in tanto in tutto il corpo per il nervosismo. Dopo avere atteso per qualche istante che rispondesse, Martin proseguì.
«E ora vuoi far rinascere il nostro amore, vuoi che ci sposiamo, vuoi me. Ma se… se i miei libri fossero passati inosservati io sarei stato esattamente quello che sono adesso. E tu te ne saresti stata alla larga da me. Sono questi fottuti libri…».
«Non parlare così», l’interruppe lei.
Quel rimprovero lo fece trasalire. Scoppiò in una rauca risata.
«Ecco la prova», disse. «In un momento critico, quando sembra che sia in gioco la tua felicità, tu hai paura della vita, come sempre, hai il terrore di una sana parolaccia».
Sferzata da quelle parole, capì la sciocchezza commessa nell’interromperlo in quel modo, e tuttavia provò risentimento verso di lui perché le sembrava che egli ne avesse accentuata la gravità. Per parecchio tempo rimasero seduti in silenzio, lei in preda alla disperazione e lui riflettendo amaramente sulla fine di quell’amore. Comprese, infine, di non averla mai amata veramente. Aveva vagheggiato una Ruth idealizzata, un’eterea creatura che egli stesso aveva creato, lo spirito sfolgorante e radioso delle sue poesie d’amore. Ma non aveva mai amato la vera Ruth, la borghese con tutti i difetti della sua classe, con la mente stretta dalla tremenda morsa della psicologia borghese.
All’improvviso lei cominciò a parlare.
«So che molto di quello che hai detto è vero, che ho avuto paura della vita, che non ti ho amato abbastanza. Ma ora sono cambiata. Ti amo per ciò che sei, per quello che sei stato, persino per il modo in cui sei giunto a questa posizione. Ti amo per le cose in cui sei diverso da quella che chiami la mia classe, per le convinzioni che non capisco ma sono certa di poter arrivare a comprendere. Mi dedicherò a questo compito con tutte le forze. E persino il fumo e le parolacce… amerò anche quelli perché sono una parte di te. Posso ancora migliorare. Negli ultimi dieci minuti ho imparato molto. Il semplice fatto di essere venuta qui è un segno dei progressi che ho fatto. Oh, Martin!…».
Singhiozzando si rannicchiò di nuovo fra le braccia di lui, che per la prima volta, mosso a pietà, la strinse dolcemente. Lei se ne accorse e alzò verso di lui un viso sorridente.
«È troppo tardi», disse Martin. Gli erano tornate alla mente le parole di Lizzie. «Sono malato… oh, non nel corpo, ma nell’anima, nel cervello. Mi sembra di avere smarrito ogni valore, di essere indifferente a tutto. Se tu mi avessi detto queste cose qualche mese fa sarebbe stato diverso. Ora è troppo tardi».
«Non è troppo tardi», esclamò Ruth, «e te lo dimostrerò. Ti proverò che il mio amore è immenso, che per me conta più della mia classe e di tutto ciò che mi è più caro. Disprezzerò quanto la borghesia considera più prezioso, non avrò più paura della vita. Lascerò mio padre e mia madre, il mio nome sarà sulla bocca di tutti. Verrò da te subito, anche adesso, diventerò la tua amante, orgogliosa e felice di stare con te. Ho tradito l’amore ma ora sono pronta a rinnegare tutto ciò che mi ha spinto a tradirlo».
Lo fissò con occhi sfavillanti.
«Sono in attesa che tu mi accetti, Martin», sussurrò. «Guardami».
Era avvenuta una cosa stupenda, pensò Martin. Superando le ferree leggi delle convenzioni borghesi, e riscattando tutte le debolezze di un tempo, Ruth era finalmente diventata una vera donna. Era una cosa stupenda, magnifica e disperata. E tuttavia doveva esserci qualcosa che non andava in lui, perché non provava alcuna commozione o entusiasmo per quanto Ruth aveva fatto. Era un’ammirazione di natura puramente intellettuale. In quello che sarebbe dovuto essere un momento esaltante, lui la valutava freddamente. Il suo cuore era lontano. Non provava alcun desiderio per lei. E gli tornarono in mente ancora una volta le parole di Lizzie.
«Sono malato, molto malato», ripeté con un gesto di disperazione. «Prima d’ora non pensavo che fosse così grave. Mi deve essere capitato qualcosa. Della vita non ho mai avuto paura, ma non avrei immaginato di esserne nauseato. L’ho vissuta così intensamente che non sento più voglia di nulla. Se mi fosse rimasto un po’ di desiderio sarebbe tutto per te. Ma vedi come sono ridotto».
Reclinò la testa indietro e chiuse gli occhi; e come un bambino piangendo dimentica il dolore nella visione della luce solare che gli penetra nelle pupille attraverso il filtro delle lacrime, così Martin perse la coscienza del proprio male, della presenza di Ruth e di tutto il resto nell’intrico di foglie e di rami che i raggi del sole disegnavano sul velo delle palpebre abbassate. Ma era un’ombra che non dava riposo. Il bagliore di quelle macchie luminose era così forte che egli provava dolore nel guardarle. Ciò nonostante non riusciva a distogliere gli occhi, e non sapeva perché.
Tornò in sé risvegliato dal rumore della maniglia. Ruth era alla porta.
«Come posso uscire?», gli chiese con voce di pianto. «Ho paura».
«Oh, perdonami», esclamò balzando in piedi. «Non sono più io. Ho dimenticato che eri qui», disse battendosi la testa con la mano. «Come vedi in me c’è qualcosa che non funziona. Ti accompagno a casa. Possiamo uscire dalla porta di servizio. Non ci vedrà nessuno. Abbassa il velo e tutto andrà bene».
Lei si strinse a lui lungo i corridoi male illuminati e le scale strette.
«Ora sono al sicuro», disse la ragazza quando furono sul marciapiede cercando di sfilare la mano dal braccio di Martin.
«No, no, ti porto a casa».
«No, per favore, non venire», protestò lei. «Non è necessario».
E di nuovo tentò di liberare la mano. Egli fu sorpreso che la ragazza avesse tanta paura quando non correva più alcun pericolo. Era quasi in preda al panico. Non riusciva a capirne il motivo e l’attribuì al nervosismo. Trattenne quindi la mano di lei al proprio braccio e si avviò al suo fianco. A metà dell’isolato vide un uomo con un lungo soprabito ritirarsi all’ombra di un androne. Nel passarvi davanti lanciò un’occhiata all’interno e, nonostante il bavero rialzato, fu certo di riconoscere Norman, il fratello di Ruth.
Durante il tragitto parlarono pochissimo. Lei era turbata e lui apatico. Una volta lui alluse al progetto di abbandonare il paese per tornare ai Mari del Sud e in un altro momento lei gli domandò di perdonarla di essere venuta a trovarlo. Fu tutto. Alla porta della casa di lei si separarono in modo convenzionale. Dopo essersi data la buona notte si strinsero la mano, e Martin si tolse il cappello. Quando l’uscio si fu richiuso egli accese una sigaretta e si volse per tornare all’albergo. Giunto al portone nel quale aveva visto infilarsi Norman si fermò a scrutarvi dentro.
«Ha mentito», disse ad alta voce. «Mi ha fatto credere di avere sfidato grandi pericoli mentre sapeva di essere aspettata dal fratello che l’avrebbe riportata a casa». Scoppiò in una risata. «Ah, questi borghesi! Quando ero un povero disgraziato non ero degno neppure di apparire al fianco di sua sorella. Adesso che ho il conto in banca, è lui stesso che me l’accompagna fino in camera».
Mentre girava i tacchi per andarsene si sentì apostrofare alle spalle da un vagabondo che camminava nella stessa direzione.
«Ehi, capo, non avresti un quarto di dollaro per pagarmi un letto da dormire?».
Il suono di quella voce fece girare Martin, che immediatamente si trovò a stringere la mano a Joe.
«Ricordi quella volta che ci siamo salutati a Hot Springs?», gli diceva l’altro. «Ti ho detto che ci saremmo rivisti. Me lo sentivo. Ed eccomi qua».
«Ti trovo bene», disse Martin con ammirazione. «Sei ingrassato».
«Ci puoi giurare», rispose Joe con un luminoso sorriso. «Prima di cominciare a fare il vagabondo non sapevo che cos’era la vita. Sono aumentato di una dozzina di chili e sto come un papa. Ai vecchi tempi ero tutto pelle e ossa. La vita nelle strade è quello che fa per me».
«Però sei alla ricerca di un letto», osservò Martin, «e la notte è fredda».
«Io, cercare un letto? Ma va!», ribatté Joe infilandosi la mano nella tasca dei pantaloni e tirandone fuori una manciata di monete. «È così che si fa la grana», aggiunse esultante, «e tu avevi proprio l’aria di un buon pollo. Ecco perché ti ho beccato».
Martin rise e rinunciò a proseguire la discussione.
«Devi averne parecchi di boccali, in quel pancione», disse in tono scherzoso.
Joe si rimise i soldi in tasca.
«Per niente», esclamò. «Con le sbornie ho chiuso anche se niente mi proibisce di bere. È solo che io non voglio. Da quando ci siamo lasciati mi sono sbronzato una volta sola, e anche quella è stata senza volere, perché ho trincato a stomaco vuoto. Quando lavoravo come un animale bevevo come un animale. Adesso che vivo come un uomo bevo come un uomo… solo un goccetto ogni tanto, tutto qui».
Martin lo lasciò con l’intesa che si sarebbero visti il giorno seguente e proseguì per l’albergo. Si fermò al banco a controllare la partenza delle navi. La Mariposa sarebbe salpata per Tahiti fra cinque giorni.
«Domani mi prenoti per telefono una cabina di prima classe», disse all’impiegato. «Non sul ponte, ma giù, dal lato di sopravvento… a dritta, si ricordi, a dritta. Se lo scriva per favore».
Quando fu in camera sua andò a letto e cadde nel sonno dolcemente, come un bambino. Gli avvenimenti di quella sera non avevano lasciato in lui alcuna traccia. La sua mente era refrattaria alle impressioni. Il piacere che aveva provato incontrando Joe era durato un attimo. Dopo pochissimi minuti aveva cominciato a provare fastidio per la presenza dell’ex lavandaio e la necessità di sostenere la conversazione. Il fatto che cinque giorni dopo sarebbe partito per gli amati Mari del Sud non gli diceva nulla. Chiuse quindi gli occhi e dormì come sempre placidamente per otto ore di un sonno quieto e ininterrotto, senza cambiare mai posizione e senza sognare. Addormentandosi precipitava in un oblio totale e ogni volta che si risvegliava ne era dispiaciuto. La vita era per lui fonte di irritazione e tedio, e il lento scorrere del tempo lo rendeva inquieto.
XLVI
«Senti, Joe», disse a mo’ di saluto al vecchio compagno di lavoro la mattina dopo, «c’è un francese che ha un negozio sulla Ventottesima Strada. Ha fatto una barca di soldi e ora torna in Francia. È una piccola e graziosa lavanderia a vapore, fine e bene attrezzata. Ecco una possibilità per te se vuoi sistemarti. Prendi questi. Va a comprarti un vestito e trovati nell’ufficio di questo tale alle dieci. È uno che è andato a vedere il locale per conto mio. Te lo farà visitare e se ti piacerà, e troverai che il prezzo di dodicimila è giusto, fammelo sapere e sarà tuo. Ora va’, perché ho da fare. Ci vediamo più tardi».
«Senti, Mart», disse l’altro lentamente ma sempre più irritato, «sono venuto qui stamattina per stare con te. Chiaro? Non per questo accidenti di lavanderia. Io vengo per fare una chiacchierata con un vecchio amico e tu mi sbatti in faccia questo affare. Va’ all’inferno, tu e la tua lavanderia».
Stava per precipitarsi fuori dalla stanza quando Martin lo prese per una spalla facendolo girare.
«Guarda, Joe», disse, «che se fai così ti arriva un cazzotto in faccia. E siccome sei un vecchio amico sarà molto forte. Chiaro? Hai capito o no?».
Joe si era messo sulla difensiva e cercava di reagire, divincolandosi e spingendo per sottrarsi alla stretta dell’altro. Avvinghiati fecero qualche passo per la camera finché non si abbatterono su una sedia di vimini che scricchiolò. Joe era sotto, con le braccia distese e il ginocchio dell’avversario sul petto. Quando Martin lo liberò ansimava e respirava con affanno.
«Voglio dirti solo due parole», riprese Martin. «Con me non la puoi spuntare. Prima di tutto concludiamo questa faccenda della lavanderia, poi potrai tornare a chiacchierare dei vecchi tempi. Ti ho detto che avevo da fare. Guarda un po’ che roba!».
Un cameriere era appena entrato con la posta della mattina, costituita da una grande massa di lettere e riviste.
«Come posso occuparmi di tutte queste carte e contemporaneamente parlare con te? Vai a fissare la lavanderia e poi potremo stare insieme».
«Bene», rispose Joe riluttante. «Pensavo che tu volevi respingermi, ma forse mi sono sbagliato. Ma se facciamo la boxe non mi batti, Mart. Ho un allungo migliore del tuo».
«Un giorno ci mettiamo i guantoni e vediamo», disse Martin con un sorriso.
«Certo, appena ho messo a posto la lavanderia». Joe stese il braccio. «Vedi che allungo? Resisterai poche riprese».
Martin emise un sospiro di sollievo quando la porta si fu chiusa alle spalle del lavandaio. Stava diventando asociale. Ogni giorno gli riusciva sempre più difficile comportarsi in modo corretto con la gente. Si sentiva turbato dalla presenza degli altri e irritato dai loro tentativi di conversazione. Gli provocavano un senso di irrequietezza e a ogni tentativo altrui di stabilire un contatto cercava tutti i pretesti possibili per sottrarvisi.
Non affrontò subito la corrispondenza e per mezz’ora ciondolò sulla poltrona senza fare nulla, con la mente occupata di tanto in tanto da pensieri vaghi e indistinti, uniche forme di un’elementare attività intellettuale.
Si scosse da questo torpore e cominciò a curiosare nella posta. C’erano una dozzina di richieste di autografi, che riconobbe come tali a prima vista; c’erano le normali domande di un aiuto economico; e c’erano le lettere piene delle pretese più assurde, dall’inventore che presentava un modello funzionante di moto perpetuo, allo pseudoscienziato che dimostrava come la superficie della terra fosse all’interno di una sfera vuota, all’uomo che cercava un finanziamento per l’acquisto della penisola della Bassa California per fondarvi un’organizzazione comunista. C’erano lettere di donne che chiedevano di conoscerlo, e fra queste una che lo fece sorridere perché accludeva, come prova di buona fede e di rispettabilità, la ricevuta del pagamento per l’affitto del banco della chiesa.
Editori e direttori di giornali diedero il loro solito contributo alla mole di posta, i primi con suppliche perché desse loro l’onore di pubblicare i suoi libri, i secondi in ginocchio per riuscire ad avere da lui racconti e articoli – quei poveri e disprezzati manoscritti che per lunghi e tristi mesi lo avevano costretto a tenere al banco dei pegni tutti gli oggetti personali per comprare i francobolli per spedirli. C’erano assegni inattesi per diritti di pubblicazioni a puntate su periodici inglesi o per anticipi su traduzioni estere. Il suo agente in Inghilterra gli annunciò la vendita di diritti di traduzione in tedesco di tre suoi libri e lo informò che le edizioni svedesi, per le quali non avrebbe ricevuto neanche un soldo perché la Svezia non riconosceva la Convenzione di Berna, erano già sul mercato. C’era poi una richiesta ufficiale perché concedesse l’autorizzazione a una traduzione in lingua russa – paese che era anch’esso, per altro, fuori della Convenzione di Berna.
Passò all’enorme fascio di ritagli speditogli dall’ufficio stampa a conferma del fatto che era diventato uno scrittore acclamato e di moda. Tutto il prodotto del suo sforzo creativo era stato gettato addosso ai lettori in un solo colpo straordinario. Quella era la ragione del suo successo. Aveva colto il pubblico di sorpresa, travolgendolo, proprio come Kipling, il quale, quasi in punto di morte, cominciò improvvisamente a essere letto dalla folla, animata dalla solita spinta conformista della massa. Martin ricordò come questa stessa moltitudine, dopo averlo letto e applaudito senza capirlo minimamente, pochi mesi più tardi si era gettata su di lui e lo aveva fatto a pezzi. Sogghignò a quel pensiero. Chi era mai lui per non essere trattato allo stesso modo fra qualche mese? Bene, si sarebbe preso gioco della massa. Se ne sarebbe andato nei Mari del Sud, avrebbe costruito la casa di zolle d’erba, avrebbe commerciato in copra e perle, avrebbe seguito la cresta dell’onda al di là della barriera su una fragile canoa, sarebbe andato a caccia di capre selvatiche fra le balze dei monti che circondavano la valle di Taiohae.
E allora capì con estrema lucidità quanto disperata fosse la sua situazione; vide chiaramente che si trovava al centro della Valle delle Tenebre e che tutta la vita che era in lui svaniva, veniva meno, si avviava alla terra della morte. Si accorse di dormire molto e di avere un grande desiderio di sonno. In passato aveva disdegnato il riposo notturno, che gli sottraeva tempo prezioso. Rimanere in uno stato di incoscienza per quattro ore su ventiquattro voleva dire perdere quattro ore di vita. Con quanta insofferenza aveva accettato la necessità di dover dormire! Ora invece mal sopportava il vivere. Non gli piaceva. Era una cosa amara e sgradevole. Questo lo preoccupava perché un’esistenza priva dello slancio vitale era destinata a finire, anche se un remoto istinto di conservazione sopravviveva in lui spingendolo a fuggire. Volgendo lo sguardo per la stanza, il pensiero dei bagagli lo gettò nello sconforto. Decise di non farli fino all’ultimo momento e di impiegare il tempo che gli restava nell’acquisto dell’equipaggiamento.
Si mise il cappello e uscì. Lungo la strada si fermò in un negozio di armi in cui trascorse il resto della mattinata esaminando fucili automatici, cartucce e attrezzatura per la pesca. Dal momento che era un settore soggetto a rapidi mutamenti decise che avrebbe dovuto aspettare l’arrivo a Tahiti per ordinare il resto dell’occorrente, che comunque poteva benissimo procurarsi in Australia. Questa soluzione lo rallegrò perché gli evitava la sgradevole prospettiva di dover fare qualcosa. Tornò dunque soddisfatto all’albergo pregustando il piacere di allungarsi sulla comoda poltrona, ma fu molto deluso quando, aperta la porta della camera, vide Joe tranquillamente seduto proprio dove avrebbe voluto mettersi lui.
Era entusiasta della lavanderia. Aveva definito ogni cosa e sarebbe entrato in possesso del negozio già il giorno seguente. Martin si sdraiò sul letto e rimase con gli occhi chiusi mentre l’altro continuava a parlare. I suoi pensieri erano lontani – così lontani che a stento si rendeva conto della realtà che lo circondava e solo con grande sforzo rispondeva, di tanto in tanto, al suo interlocutore. E tuttavia chi gli stava davanti era Joe, una persona che gli era sempre piaciuta. Ma Joe era troppo innamorato della vita. Quel violento impatto feriva l’animo spossato di Martin, era un rovello insopportabile per la sua sensibilità dolente. Quando l’altro gli ricordò che in futuro avrebbero dovuto, una volta o l’altra, incrociare i guanti, fu sul punto di scoppiare.
«Ricordati, Joe, che devi dirigere la lavanderia secondo quelle norme di cui hai parlato a Shelly Hot Springs», disse. «Niente straordinari, niente lavoro notturno. Nessun bambino al mangano; anzi nessun bambino in negozio. E un salario equo».
Joe annuì ed estrasse un taccuino.
«Guarda un po’ qua. Stamattina prima di colazione ho fissato queste regole. Che cosa ne pensi?».
Le lesse ad alta voce a Martin, che le approvò, preoccupato che l’altro non la facesse tanto lunga e se ne andasse.
Si svegliò nel pomeriggio inoltrato riacquistando lentamente la coscienza di ciò che lo circondava. Si guardò in giro. Joe era uscito senza far rumore mentre lui era assopito. Che delicatezza da parte sua. Richiuse gli occhi e si addormentò di nuovo.
Nei giorni che seguirono Joe fu troppo preso dal lavoro di organizzazione e di presa di possesso della lavanderia per importunarlo e solo alla vigilia della partenza i giornali annunciarono che Martin aveva prenotato un passaggio sulla Mariposa. Una volta, in un raro soprassalto dell’istinto vitale, andò dal medico per sottoporsi a un attento esame. Non aveva niente. Cuore e polmoni erano in condizioni eccellenti e tutti gli altri organi furono definiti normali e perfettamente funzionanti.
«Non ha nulla, signor Eden», gli disse il dottore, «proprio nulla. Ha un fisico eccezionale. Sinceramente la invidio. Ha una salute superba. Ha un torace e uno stomaco straordinari, che sono il segreto della sua magnifica costituzione. Dal punto di vista fisico di uomini come lei se ne trova uno su mille… uno su diecimila. Salvo incidenti lei vivrà fino a cent’anni».
Martin comprese che Lizzie aveva fatto una diagnosi corretta. Fisicamente stava benissimo, ma era la testa che non andava e non c’era cura possibile se non la fuga verso i Mari del Sud. Il guaio era che adesso, alla vigilia della partenza, non aveva più alcun desiderio di andarsene e quei lidi remoti non avevano per lui più fascino di quanto ne avesse la civiltà borghese. Non provava alcuna eccitazione al pensiero del viaggio e la prospettiva di salpare lo sgomentava. Avrebbe preferito trovarsi già a bordo e in alto mare.
L’ultimo giorno fu un calvario. Avendo letto sui giornali della sua partenza, Bernard Higginbotham, Gertrude e tutti i figli vennero a salutarlo, seguiti da Hermann von Schmidt e da Marian. Dovette anche sbrigare le ultime faccende, pagare i conti rimasti in sospeso e sopportare gli immancabili giornalisti. Disse addio a Lizzie Connolly bruscamente, al portone della scuola serale, fuggendo via di corsa subito dopo. All’albergo trovò Joe, che per tutta la giornata era stato così impegnato con la lavanderia da non riuscire a venire prima. Fu l’ultima goccia di un vaso già colmo; tuttavia Martin si impose di rimanere inchiodato alla sedia per mezz’ora a sentire le chiacchiere dell’altro.
«Non devi sentirti legato a questa lavanderia, Joe», gli disse Martin. «Non deve essere una prigione. In qualunque momento puoi venderla e mangiarti tutti i soldi. Se te ne stufi o ti viene la nostalgia della strada, non pensarci due volte e pianta tutto. Fa’ quello che ti piace di più».
Joe scosse la testa.
«Basta con la vita del barbone, grazie mille. Fare il vagabondo è anche bello, ma ha un difetto. Ti mancano le ragazze. E a me piacciono molto le donne. Non posso più stare lontano da loro, e quando si vive nelle strade a queste cose bisogna rinunciare. Quante volte sono passato davanti a case dove c’erano feste da ballo e ho sentito le risate delle donne e ho visto dalle finestre i loro vestiti bianchi e le facce che sorridevano… Accidenti! Ti assicuro che in quei momenti stavo proprio male. Mi piacciono troppo le danze, le scampagnate, le passeggiate sotto la luna e tutto il resto. Che bello avere una lavanderia, e buoni vestiti, e una manciata di dollari che ti suonano nelle tasche! Ho già adocchiato una ragazza, proprio ieri, e mi sa proprio che la sposerò. È tutto il giorno che ci rimugino su. È uno schianto; ha occhi che sembrano stelle e la voce più dolce che ho mai sentito. Ho preso una bella sbandata, non c’è che dire. E tu, perché non ti sposi con tutti i soldi che butti dalla finestra? Potresti prenderti la ragazza più bella di tutta l’America».
Martin scosse il capo con un sorriso, chiedendosi in cuor suo perché mai tanti uomini volessero sposarsi. Gli pareva una cosa strana e incomprensibile.
Dal ponte della Mariposa, al momento della partenza, scorse Lizzie Connolly nascosta fra la folla assiepata sulla banchina. Portala con te, pensò. È tanto facile essere gentili. Lei ne sarebbe enormemente felice. Ma fu la tentazione di un attimo, che subito si trasformò in terrore. A quell’idea fu preso da un panico che lo fece precipitare in un’angoscia mortale. Si staccò dalla ringhiera con un gemito mormorando: «Sei troppo malato, caro mio, sei troppo malato».
Fuggì in cabina, dove rimase senza muoversi fino a quando la nave non ebbe lasciato il molo. Nella sala da pranzo, durante la colazione, si trovò al posto d’onore, alla destra del capitano; non gli ci volle molto a scoprire di essere il personaggio più importante. Ma fu il «passeggero celebre» più attediato che una crociera abbia mai avuto. Passò il pomeriggio su una sedia a sdraio con gli occhi chiusi, sonnecchiando per la maggior parte del tempo, e la sera andò presto a letto.
Dopo il secondo giorno gli altri passeggeri, superato il mal di mare, erano ricomparsi sul ponte, ma più li conosceva più provava per loro una profonda avversione. Tuttavia si rendeva conto di essere ingiusto con loro. Si costrinse ad ammettere che si trattava di persone brave e gentili; naturalmente, aggiunse subito, brave e gentili come tutti i borghesi, con tutta la grettezza mentale e la superficialità intellettuale della loro classe. Erano creature così vuote che conversando con loro si sentiva assalire da una noia mortale, mentre la cordialità rumorosa e l’energia prepotente dei più giovani lo turbava. Non stavano mai fermi, ed erano impegnati in un continuo movimento che li portava a giocare ai cerchi, a lanciare gli anelli, a passeggiare, a precipitarsi alle ringhiere con alte grida per osservare i salti dei delfini e i primi branchi di pesci volanti.
Dormiva molto. Dopo la prima colazione si rifugiava sulla sedia a sdraio con una rivista che non finì mai di leggere. Quelle pagine stampate lo stancavano. Stupito dal fatto che si potessero trovare tanti argomenti su cui scrivere, si appisolava. Quando veniva risvegliato dal gong del pranzo provava un senso di irritazione. Non trovava alcuna soddisfazione nella vita cosciente.
Una volta tentò di scuotersi da quel letargo andando nel castello di prua con i marinai, ma gli parve che la gente di mare fosse cambiata dai giorni in cui aveva prestato servizio sulle navi. Non sentiva alcuna affinità con quelle creature bestiali dalla faccia ottusa e dall’intelligenza bovina. Era disperato. Nelle alte sfere nessuno aveva voluto Martin Eden per se stesso, e ora non poteva fare ritorno alla propria classe che in passato lo aveva accettato. Non si sentiva attratto da loro. Non li poteva sopportare, proprio come non riusciva a digerire gli stupidi passeggeri della prima classe e i giovani vocianti.
La vita gli faceva lo stesso effetto di una forte luce bianca sugli occhi affaticati di un malato. Nei momenti in cui era cosciente essa divampava intorno a lui investendolo con violenti bagliori che bruciavano, bruciavano in modo intollerabile. Era la prima volta che Martin viaggiava in prima classe. Durante la navigazione in mare era sempre stato nel castello di prua, ai comandi o impegnato a passare carbone nelle nere profondità della stiva. A quel tempo, riemergendo dal pozzo di salita dopo ore passate in quel soffocante calore e scorgendo i passeggeri nei loro freschi abiti bianchi, di null’altro preoccupati che di divertirsi, sotto tendoni distesi per proteggerli dal sole e dal vento, assistiti dal servizievole personale di bordo che esaudiva ogni loro desiderio e capriccio, gli era sembrato che il mondo in cui queste creature vivevano e si muovevano fosse il paradiso. Ed ora che, nella sua qualità di persona importante, di questo luogo era il re, e sedeva alla destra del capitano, si volgeva senza speranza al castello di prua e alla stiva del combustibile alla ricerca del paradiso che aveva perduto. Non aveva trovato il nuovo e al vecchio non poteva tornare.
Cercò di reagire e di fare qualcosa che lo interessasse. Tentò alla mensa sottufficiali e fu contento di venirsene via. Parlò con un timoniere fuori servizio, un uomo intelligente che subito ne approfittò per fare propaganda socialista e per costringerlo a prendere un fascio di opuscoli e volantini. Ascoltando l’uomo che esponeva la sua moralità da schiavo ripensò quasi con indifferenza alla filosofia di Nietzsche. Che cosa ne restava? Ricordò una delle folli proposizioni in cui quel pazzo filosofo aveva dubitato della verità. Che dire? Forse aveva ragione. Forse non c’era verità in niente, non c’era verità nella verità – e la verità non esisteva. Ma presto si stancò di quei ragionamenti e fu lieto di riprendere a sonnecchiare sulla sedia a sdraio.
Alla tristezza che provava sulla nave presto si aggiunse una nuova fonte di infelicità. Che cosa avrebbe fatto quando fossero arrivati a Tahiti? Sarebbe dovuto scendere a terra. Avrebbe dovuto ordinare l’equipaggiamento che gli serviva, trovare un passaggio su una goletta diretta alle isole Marchesi e occuparsi di infinite altre cose che gli ripugnavano al solo pensarci. Ogni qual volta, con uno strenuo sforzo, cominciava a riflettere, vedeva in che grave situazione si trovava. Ormai era nella Valle delle Tenebre e il pericolo era dovuto al fatto che non sentiva paura. Se avesse avvertito un qualche timore si sarebbe diretto verso la vita invece di addentrarsi sempre più profondamente nel buio. Non provava più piacere nelle vecchie cose di un tempo. La Mariposa era adesso in mezzo ai venti del nord est, ma essere avvolto da questa deliziosa brezza lo irritava e fece spostare la sedia a sdraio per sfuggire all’abbraccio dell’allegro compagno di tanti giorni e tante notti.
Quando la nave entrò nella bonaccia Martin fu più infelice che mai perché non poteva più dormire. Pur cascando di sonno era costretto a rimanere sveglio e a sopportare la cruda luce dell’esistenza. Si muoveva irrequieto in quell’aria umida e appiccicosa cui gli acquazzoni non portavano alcun refrigerio. La vita era una sofferenza, che lo spingeva a camminare sul ponte fino a quando quell’esercizio diventava insopportabile, e a sedersi finché l’inquietudine non lo costringeva ad alzarsi di nuovo. Infine si impose di finire la lettura della rivista e di prendere in prestito dalla biblioteca della nave diversi volumi di poesia. Ma neppure quelli riuscirono a tenerlo fermo e ancora una volta riprese a passeggiare.
Dopo cena rimaneva sul ponte fino a tardi, ma ciò non lo aiutava perché, quando scendeva in cabina, non riusciva a dormire. Gli era venuta meno anche la risorsa dell’estraniazione dalla vita. Accese la luce elettrica e tentò di leggere. Uno dei libri era di Swinburne. Sdraiato sul letto sfogliò le pagine distrattamente finché improvvisamente si accorse di leggere con interesse. Finita la strofa, cercò di continuare, ma sentì l’impulso di rileggere. Si appoggiò quindi il libro sul petto con le pagine aperte verso il basso e cominciò a riflettere. Si era imbattuto proprio in quello che cercava. Strano che non l’avesse visto prima. Era la soluzione a tutti i suoi problemi. Dopo essere andato alla deriva per tanto tempo, Swinburne gli aveva indicato la via. Il riposo che bramava era lì, a portata di mano. Guardò l’oblò. Sì, era abbastanza grande. Per la prima volta dopo settimane e settimane si sentì felice. Aveva finalmente scoperto il rimedio al suo male. Sollevò il libro e lesse la strofa ad alta voce:
«Liberati dal soverchio amor della vita,
Dalla speranza e dalla paura,
Inchiniamoci brevemente
Agli dei, quali che siano,
Grati di questo almeno:
Che ogni vita un giorno si spenga,
I morti levarsi non possano
E persino i fiumi più stanchi
Sfocino alfine nel mare».
Guardò di nuovo il finestrino spalancato. Swinburne gli aveva aperto gli occhi. La vita era, o meglio era diventata, una cosa terribile, insopportabile. «I morti levarsi non possano!». Quel verso suscitava in lui un profondo sentimento di gratitudine. Era la sola prova di carità che esistesse nell’universo. Quando il vivere era un tormento implacabile, la morte era la via che permetteva di rifugiarsi dolcemente nel sonno eterno. Ma che cosa stava aspettando? Era il momento di andare.
Si alzò e sporse la testa dall’oblò, a poca distanza dallo schiumoso biancore del mare. Dal momento che la Mariposa era profondamente immersa nell’acqua a causa del forte carico, sarebbe potuto arrivare a toccare l’acqua con i piedi attaccandosi con le mani al bordo del finestrino e quindi scivolare dentro senza fare rumore. Non avrebbe sentito nessuno. Fu investito sulla faccia da uno spruzzo di cui avvertì il sapore salato sulle labbra. Era buono. Si chiese se dovesse scrivere un canto del cigno, ma rise a quel pensiero. Non c’era tempo. Era impaziente di andare.
Spenta la luce della cabina per non correre il rischio di essere scoperto uscì dall’oblò con i piedi in avanti. Fu bloccato dalla larghezza delle spalle e costretto a rientrare; riprovò tenendo un braccio disteso lungo il fianco. Aiutato dal rollio della nave uscì infine con tutto il corpo, rimanendo attaccato al bordo con le mani. Si lasciò andare quando i piedi toccarono il mare e si ritrovò nella lattea spuma dell’acqua. La murata della Mariposa lo superò velocemente come una nera parete mobile rotta qua e là dalle luci degli oblò. Stava andando forte. Un attimo dopo vide la poppa che si allontanava, mentre egli rimase a nuotare lentamente nella frantumata schiuma della scia.
Rise quando il suo bianco corpo fu urtato da uno squalo, ma il bruciore dei denti del pesce gli ricordò perché si trovava lì. Se n’era dimenticato nell’ansia di riuscire ad abbandonare in fretta la nave. Mentre le luci della Mariposa si affievolivano in lontananza, rifletté che stava nuotando tranquillamente come se la sua meta fosse la terra più vicina, a mille chilometri di distanza.
Agiva automaticamente, sospinto dall’istinto vitale. Smise di muovere braccia e gambe, ma non appena sentì l’acqua salirgli alla bocca sferzò subito il mare con le mani. È la volontà di vivere, si ripeté sprezzante. Bene, doveva esercitare quella volontà in un ultimo disperato sforzo di autodistruzione e di annullamento di sé.
Mise il corpo in posizione verticale. Alzando lo sguardo alle gelide stelle del cielo svuotò i polmoni dell’aria. Quindi con un colpo rapido e vigoroso dei piedi e delle mani sollevò le spalle e la parte superiore del busto per guadagnare forza nella spinta verso il basso. Si lasciò quindi andare sott’acqua, una bianca statua che precipita nel mare. Una volta immerso respirò deliberatamente con forza come si fa quando si deve andare in anestesia. La sensazione di soffocamento lo costrinse però a muovere involontariamente braccia e gambe su fino alla superficie, alla chiara presenza delle stelle.
«Volontà di vivere», pensò di nuovo con sdegno, cercando invano di non immettere aria nei polmoni che gli scoppiavano. Bene, avrebbe dovuto fare in un altro modo. Decise di immagazzinare nel petto quanta più aria poteva e di scendere in profondità. Si immerse a testa in giù e prese a inabissarsi sempre di più nuotando con grande forza. Tenendo gli occhi aperti notò le forme spettrali e fosforescenti dei velocissimi squali. Si augurò che non lo assalissero perché ciò poteva fiaccare la sua determinazione. Non lo fecero e trovò il tempo di ringraziare la vita per quest’ultima cortesia che gli aveva concesso.
Andò giù, sempre più giù finché la stanchezza delle braccia e delle gambe fu tale che non riusciva quasi a muoversi. Capì di essere sceso molto perché sentiva una pressione dolorosa alle orecchie e un ronzio alla testa. Stava per cedere, ma costrinse gli arti a portarlo ancora più sotto fino a quando la capacità di resistenza venne meno e l’aria gli uscì dai polmoni con la violenza di un’esplosione, avvolgendogli le guance in mille bollicine che salivano rapidamente. Quando cominciò il dolore e il soffocamento pensò che non era ancora la morte. La morte non faceva male. Era la vita con i suoi spasimi, con le sue terribili sensazioni; e quello era l’ultimo colpo che gli dava.
Ostinatamente mani e piedi cominciarono a vorticare frenetici, ma con un movimento sempre più debole: era riuscito astutamente a sconfiggere la loro volontà di vivere. Era sceso troppo e non sarebbero più stati capaci di riportarlo in superficie. Gli parve di essere languidamente alla deriva in un mare di visioni fantastiche, che lo circondavano cullandolo e accarezzandolo. Dov’era? Gli sembrò di trovarsi in un faro; era invece il suo cervello che emanava una luce bianca, accecante, che roteava sempre più veloce. Seguì un suono cupo e rombante che lo precipitò giù per una smisurata tromba di scale, al fondo della quale, a un certo punto, cadde nella tenebra. Questo solo capì. Di essere caduto nella tenebra. E nell’istante in cui seppe, cessò di sapere.
DE OTROS MUNDOS
Los escritores y sus enfermedades / Cuando el genio literario emerge del sufrimiento
DRAGON
The 100 best novels / No 35 / The Call of the Wild by Jack London (1903)
How to Make a Living as a Writer, According to Jack London
RIMBAUD
Jack London / L'appel de l'écriture
DANTE
Jack London I / Un testamento a tutti gli effetti
Jack London II / Nato per comandare
Jack London III / La Fine
DE OTROS MUNDOS
Los escritores y sus enfermedades / Cuando el genio literario emerge del sufrimiento
DRAGON
The 100 best novels / No 35 / The Call of the Wild by Jack London (1903)
How to Make a Living as a Writer, According to Jack London
RIMBAUD
Jack London / L'appel de l'écriture
DANTE
Jack London I / Un testamento a tutti gli effetti
Jack London II / Nato per comandare
Jack London III / La Fine



Nessun commento:
Posta un commento