(“I fieri camminatori”, p. 49)
C’è in queste poche parole buona parte del senso delle storie di James Still, tra gli autori di riferimento della Appalachian and Southern literature: le piccole comunità agricole nell’America rurale dopo la Grande Depressione, i desideri semplici, la quotidiana lotta contro la fame. E l’immediatezza di una lingua che non deve essere stato per niente facile tradurre – plauso a Livio Crescenzi e Tonina Giuliani – perché intrisa di oralità e vocabolario peculiare. Considerato tra i più importanti autori della Southern Reinassance, Still è in Italia scoperta recente, grazie alle traduzioni per Mattioli 1885 che ha prima portato i due romanzi più celebri, Fiume di terra (2018) e Chinaberry (2019), e in seguito due pregevoli raccolte di racconti, Le colline ricordano (2020) e
L’incendio delle acque (2021) appena pubblicata che contiene anche diverse storie inedite. Curioso che questo gigante della letteratura statunitense non fosse stato tradotto prima in italiano, magari sulla scia dell’interesse per un certo tipo di ambientazione che ha coinvolto la nostra ricezione della letteratura nordamericana degli ultimi anni. Quali che siano le ragioni, è ancora una volta una casa editrice indipendente e autorevole come Mattioli a proporre ai lettori l’opera più significativa di un autore senza confini di forma e che ben si inserisce nel più ampio discorso letterario contemporaneo, pur con narrazioni nate in un ben connotato contesto sociale e cronologico.
C’è qualcosa in questi racconti, un sentire e un’universalità, che vanno ben oltre confini geografici e temporali, pienamente capace di dialogare con il lettore contemporaneo. Quello stesso lettore che legge
Chris Offutt, Ron Rash, Wendell Berry e James Allen Lane – solo per citare alcuni tra gli autori legati al Kentucky – , interessato alle narrazioni di una realtà rurale stretta fra le montagne, in zone impervie dove la natura non ha alcuna connotazione mistica ma è molto spesso spietata e la fatica, la consuetudine alla morte e alla violenza, si intrecciano al quotidiano. Autori molto diversi fra loro ma legati a quei luoghi in cui sono nati o che hanno scelto, e ai quali sono tornati come Still, dopo i numerosi viaggi e studi e la sua decisione di vivere quasi come un eremita in una capanna nei boschi sugli Appalachi. E rendersi presto conto che le storie che doveva raccontare erano proprio lì davanti a lui, tra quelle montagne, tra le vite che ben conosceva, isolate in quegli spazi ristretti e impervi ma non meno degne di farsi letteratura. Le piccole comunità agricole che si scontrano con l’industrializzazione, le miniere in esaurimento e la vita che ci gira intorno e ne dipende, l’isolamento e la solitudine in una natura aspra e selvaggia, il lavoro e la fatica: era tutto davanti a lui, e Still riesce a imprimere sulla pagina il contrasto tra fatica e dignità di uomini e donne – ma pure bambini – che nonostante tutto non cedono allo sconforto; non perché le storie si risolvano in happy ending – capita decisamente di rado – ma nel senso di una capacità di mantenere intatta, nonostante tutto, la forza di andare avanti, conservando una dignità che contrasta fortemente con un certo tipo di narrazione sulla povertà cui siamo abituati. Uomini e donne che sopportano un isolamento logorante, la solitudine che pare gonfiarsi «dentro di noi, enorme come un mucchio di ghiande». Un quotidiano precario, dove ogni cosa può andare perduta da un giorno all’altro, rappresentano una condizione cui è necessario abituarsi presto nel tentativo di sopravvivere.
Brevi lampi di speranza a squarciare la pagina, qualche risata di bambini e i borbottii di mogli che lottano contro mariti testardi, desideri semplici: una casa con dei buoni vicini, appunto, una camicia comprata in un negozio, scorte di cibo sufficienti per tutti.
Le verdure selvatiche presero il posto dei fagioli e dei conigli. Mangiavamo cespi di lattuga selvatica, stracciabraghe, borragine e cicoria di campo. E di nuovo fagioli e coniglio, quando le piante divennero dure e fibrose. Verso la fine di aprile la carne salata si era ormai ridotta alla cotenna, il sacco del cibo era più sacco che pane, il lardo poco o niente. Papà dissodò un fazzoletto d’orto e poi lasciò che fosse Mamma a occuparsi delle semina e della coltivazione. Lui si dedicò anima e corpo alla ricerca del ginseng. Tornava a casa troppo esausto per battibeccare appresso a noi e di rado vedeva il piccolo sveglio. Dan iniziò a guardarlo di traverso. E quanto alle scarpe, ormai rattoppava le toppe.
(“L’incendio delle acque”, p. 201)



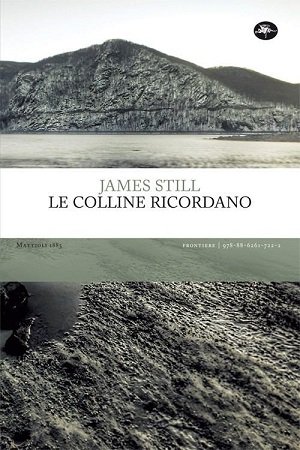

Nessun commento:
Posta un commento