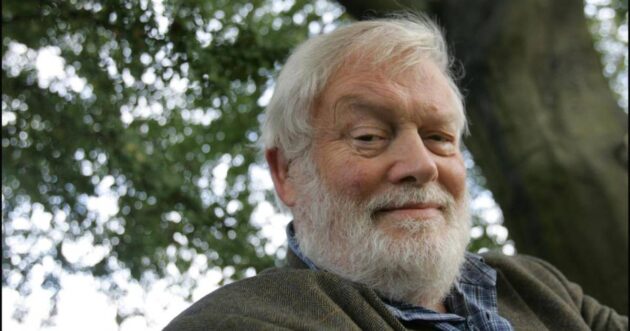Uscirne vivi
Alice Munro, il marito maniaco e i danni della semicultura sulle menti deboli
Scopriamo adesso che nel 1976 la terzogenita della scrittrice canadese subì abusi sessuali dal patrigno, ma la madre decise di non lasciare il compagno. Ora naturalmente è partita l’indignazione social contro la Nobel 2013, ma invece andrebbe letta con attenzione per cogliere la disperazione letteraria di chi pur di non restare sola ha accettato di

Il 2013 è l’anno in cui ad Alice Munro viene assegnato il Nobel per la letteratura. È anche l’anno in cui muore Gerald Fremlin, il suo secondo marito. Che otto anni prima è stato condannato da un tribunale perché, quando Andrea Munro aveva nove anni ed era andata a trovarli d’estate, si era fatto una sega addosso a lei – che saggiamente aveva finto di dormire – e simili amenità.
Era successo nel 1976, e Andrea, terzogenita di Alice, tornata a casa l’aveva detto subito alla moglie del padre. Che l’aveva detto al padre, il quale non ne aveva poi mai parlato con Andrea né con Alice ma, dall’estate successiva, aveva mandato Jenny, la sorella di Andrea, ad accompagnarla nelle vacanze a casa della madre e del maniaco.
Nel 1992, Alice Munro dice alla figlia che ha letto un racconto in cui una ragazzina si suicida per essere stata vittima d’incesto, e le chiede: perché non l’ha detto alla madre? A quel punto Andrea pensa di poterle raccontare che gran porco sia il suo secondo marito, fino ad allora si era sentita in colpa, o aveva avuto paura che fosse la madre a colpevolizzarla. Le scrive una lettera.
Ne derivano le dinamiche melodrammatiche proprie di tutte le famiglie: Alice Munro si sente tradita da Gerald, delusa da Andrea, in generale è preoccupata di sé ben prima che della figlia. È una curva comportamentale assai realistica ma trascuratissima dalla drammaturgia: chissà perché rappresentiamo quasi solo madri pronte a tutto per difendere i figli, mai pronte anche a calpestare i figli pur di tenersi un marito.
Alice se ne va brevemente di casa. Ed è a questo punto che la storia diventa la storia di tutti noi ogni giorno: sì, magari una storia di violenza e reati, ma soprattutto una storia di stupidità. Gerald scrive delle lettere. Delle lettere in cui dice che sì, vabbè, ha tentato di farsi fare una sega da una bambina di nove anni, e visto che lei si ostinava a dormire alla fine s’è limitato a strusciarsi su di lei, a metterle le mani nelle mutande, a menarselo: ma è perché lei è Lolita.
E, se una Lolita mi seduce, io posso diventare Humbert, se mostra un’attrazione sessuale per me io reagisco, scrive l’imbecille parlando d’una bambina di nove anni. Gerald è sposato con una scrittrice, e il fatto che pensi di poter usare “Lolita” in propria difesa è l’arringa definitiva sui danni che la semicultura può fare sulle menti deboli. Può uno essere così imbecille da mettere per iscritto roba del genere, da minacciare di rovinare la reputazione alla fu puttanella novenne se qualcuno osa denunciarlo? Certo che può, ed è solo grazie a quelle lettere e alle ammissioni di colpa che contengono che molti anni dopo Andrea riuscirà a farlo condannare da un tribunale.
Perché, dice nel racconto della vicenda uscito sul Toronto Star, voleva che questa storia non restasse segreta. Che fosse parte della biografia della madre. Di quella madre che, nonostante le lettere, tornò dal marito. «Mi disse che senza di lui non poteva vivere», racconta la primogenita Sheila: gratta una scrittrice premio Nobel, e troverai una servetta romantica.
Andrea voleva che tutti sapessero, e invece Alice Munro è morta due mesi fa con la reputazione intonsa. Eravamo tutti distratti da Roman Polanski e Woody Allen, e nessuno – neanche Claire Dederer, che sul tema ha scritto un libro, “Mostri” – ha ritenuto che il dibattito sul separare l’opera dall’autore dovesse coinvolgere una donna, una madre che si riprende il marito che ha esercitato violenza su sua figlia perché, racconta Andrea che le rispose Alice, è una cultura misogina quella che vuole ch’io rinunci a mio marito. Ma certo, Alice. Una cultura misogina quella che ti dice che non è che devi proprio tenerti il marito a tutti i costi.
La settimana scorsa, una donna che a tredici anni è stata violentata dal prozio dal quale era stata mandata a lavorare d’estate ha scritto a Kwame Anthony Appiah, che sul New York Times tiene la rubrica “The ethicist”. Anche lei ci ha messo una quindicina d’anni a dirlo alla madre, la quale le ha risposto che le era successa la stessa cosa da ragazzina, con lo stesso parente, ma gli aveva mandato la figlia comunque perché ormai era vecchio.
Su richiesta della madre, la donna non aveva detto niente al padre, il quale però continuava a chiedersi perché lei fosse fredda con la madre (sono nel frattempo passati altri vent’anni, perché le tragedie familiari restano immobili e ignorate nel tempo come certi surgelati dimenticati in fondo al freezer – scusate la similitudine sciatta).
Quindi la tizia scrive al filosofo per sapere se dirlo adesso sia egoismo, forse rischia solo di guastare il matrimonio tra due ottantenni, e altri scrupoli del genere. Né lei che si pone questi dubbi, né lui che a questi dubbi risponde, considerano una cosa che pure a me sembrava ovvia anche prima che il Toronto Star pubblicasse la vicenda Munro: hai messo in conto che tuo padre prenda le difese di tua madre e non le tue, e tu possa restarci male il doppio?
Perché, da un punto di vista di mera drammaturgia, a me pare plausibile che finisca così. Un matrimonio cinquantennale è un meccanismo sclerotizzato, in cui prima di rinnegare la posizione storta in cui ti sei accomodato per non accorgerti di quel doloretto sei disposto a raccontarti proprio tutto, anche che tua moglie fosse in buona fede quando ha mandato la figlia da un pervertito. Lo dice proprio Andrea Robin Skinner, nata Munro, in un altro articolo pubblicato sempre dal Toronto Star: «Mio padre non voleva dire a mia madre cos’era successo perché sentiva che i bisogni di lei erano più grandi di quelli delle sue figlie». E papà Munro non era neppure più sposato con la madre: figuriamoci quando ci sono legami in corso.
Jenny, una delle sorelle di Andrea, dice che, tra le ragioni per cui in famiglia sono stati tutti zitti per anni, c’è anche la fama letteraria della madre: non volevano sembrare quelli che demolivano una donna che ormai era un simbolo. Intervistatori e biografi non so che scusa abbiano, forse la stessa: Carole, la matrigna, racconta che lo sapevano tutti, che a una cena un giornalista le chiese «ma è vera questa storia?», eppure mai una riga è uscita.
Possiamo nasconderci dietro al frasifattismo e dire che una vittima racconta quando è pronta e i tempi che sceglie sono sempre quelli giusti, o chiederci cosa ci dica la tempistica di questa confessione (Alice Munro è morta il 13 maggio): che Andrea ha voluto lasciare che la madre morisse con la reputazione intatta e il Nobel non revocato per indegnità (se hanno revocato l’Oscar a Polanski, perché non revocare ora il Nobel a Munro), o che non ha voluto darle modo di difendersi da viva (ma non l’avrebbe comunque potuto fare, in anni recenti: aveva l’Alzheimer).
La ragione per cui Andrea si decide infine a denunciare Gerald è che nel 2002 diventa madre, dice ad Alice che può vedere i nipoti ma suo marito non si deve avvicinare, e quella le risponde che per lei è molto scomodo andare a trovarla se non la accompagna lui. Lei a quel punto conclude urlando la telefonata e la frequentazione (meglio tardi che mai). Due anni dopo, a ottobre 2004, Daphne Merkin intervista Alice Munro per le pagine dei libri del New York Times.
Non solo è un’intervista in cui Alice parla di Gerald come fosse l’uomo dei sogni, ma anche in cui si dice in ottimi rapporti con tutt’e tre le figlie, «che s’incontrano per parlare di me», e pazza dei nipoti. Ogni vaso ha la sua goccia, e quella che fa traboccare Andrea è quell’intervista. Sai, Gerald: se la mamma non avesse detto al New York Times che uomo favoloso eri, magari non sarebbe finita col tuo nome nel registro dei pedofili.
Quanto alla separazione tra opera e autrice, ieri i social erano pieni di «che schifo, non la leggerò mai più», giacché ormai non esistono lettori ma consumatori, e il consumatore boicotta il prodotto se il produttore dà mostra d’immoralità. Come ci si possa non incuriosire, considerato quante madri e quante figlie ci sono nei racconti di Munro, come si possa non aver voglia di andare invece a rileggere tutto e scoprire in quanti sottotesti ci siano Gerald e Andrea, Gerald e Alice, la disperazione di chi pur di non restare sola accetterebbe proprio di tutto, l’inferno che sono le famiglie, come si possa non aver voglia d’indagare la scrittura di una che è stata umanamente così bieca io non me lo so spiegare. È pure morta: i diritti d’autore mica vanno a lei.
LINKIESTA